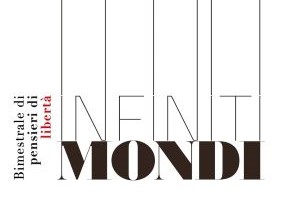La sensazione sconcertante che si ha leggendo le cronache attuali sul disastro afgano è che quel Paese sia uscito dall’oscurità della storia solo l’11 novembre 2001, con l’attacco di Al Qaida di Osama Bin Laden alle Torri gemelle e con la reazione statunitense che, attraverso l’operazione Enduring Freedom in poco più di un mese, nel novembre successivo, porta al rovesciamento del regime integralista dei talebani.
Nessuno spiega, come, quando, perché, nel cuore montagnoso dell’Asia si fosse potuto mettere in piedi uno Stato nato da una “jihad”, una “guerra santa” e fondato sulla interpretazione del tutto letterale della sharia, il complesso di regole di vita e di comportamento dettato da Dio non solo per la condotta morale e religiosa ma quale norma anche giuridica. Questa interpretata letteralmente, così come riportata dal Corano, non tenendosi in alcun conto che esso fosse frutto della cultura del VII secolo, e fosse stato da Maometto pensato per regolare la vita di un popolo nomade del deserto, vissuto ai margini delle grandi culture del mondo antico, quella persiana, quella ebraica, quella greco-romana, tanto da esserne appena lambito.
Ma non si tratta di ripartire da Maometto, o dal lontano 652 dC, quando pezzi delle montagne afgane furono annesse al Califfato Arabo Islamico.
Sarebbe bastato ai tanti commentatori odierni lo sforzo partire solo dal qualche decennio prima del 2001, slargare la riflessione di un trentennio, datarla almeno da quel fatidico 17 luglio 1973 quando un golpe nato all’interno della stessa famiglia reale, depose il re ed istituì la repubblica con l’intento di accelerare la modernizzazione del Paese e portarlo fuori da un medioevo interminabile.
E’ infatti lì, è nel breve lasso (per i tempi della storia) che separa il luglio del ’73 dall’aprile del 1992, la prima conquista di Kabul da parte del talebani del mullah Omar, che affondano le radici vere delle vicende attuali.
La storia travagliata della repubblica afghana si snoda come un film complesso e contradittorio nel quale però, questo è il punto, giocano, almeno con lo stesso peso nel determinarne gli sviluppi, assieme a ragioni legate alle vicende sociali, economiche e politiche interne di quel Paese altre che rinviano al grande gioco del domino sullo scacchiere del mondo con impegnate le grandi potenze, l’Urss e gli Usa della guerra fredda, e con la Cina, prima “convitato di pietra”, ma ai margini della partita, poi sempre più protagonista in campo.
Perché questa rimozione che riguarda tutti i commentatori politici?
Cosa è che viene taciuto da parte di chi oggi spande lacrime a litri sul fallimento della democrazia, sulla sorte delle donne, sui pericoli di un rilancio in grande stile dell’integralismo islamico e dei suoi addentellati terroristici?
Viene occultato che in quel ventennio il tentativo di costruire una nazione afgana, democratica, laica, fondata sull’eguaglianza tra sessi, e tra gli appartenenti a gruppi tribali e religiosi diversi c’è stato ed è stato effettivo. E quel tentativo fu vanificato dalla politica statunitense con la complicità dei suoi alleati e dell’opinione pubblica occidentale anche di sinistra, persino – e dispiace dirlo – di quella di formazione comunista.
Fu un partito che si può definire “comunista”, il Partito Democratico Popolare dell’Afghanistan (PDPA), che il 27 aprile 1978 con un colpo di Stato basato su gruppi ampi di militari e l’intera intellighenzia di formazione occidentale, diede vita alla “Repubblica Democratica dell’Afghanistan” che avviò una serie di riforme in campo economico come l’avvio di una riforma agraria con la distribuzione di terre a 20.000 contadini e la contestuale abrogazione dell’ushur (ovvero la decima dovuta ai latifondisti dai braccianti), la messa in cantiere di programmi di industrializzazione e di apertura del Paese al commercio internazionale. E nel contempo bandì l’usura, male atavico dei paesi sottosviluppati; regolò i prezzi dei beni primari, statalizzò i servizi sociali garantendoli a tutti e, sul piano dell’ammodernamento delle istituzioni e dei rapporti civili diede il riconoscimento al diritto di voto alle donne, legalizzò i sindacati, vietò i matrimoni forzati e lo scambio di bambine a scopo economico (in effetti la vendita delle figlie da parte dei genitori), sostituì leggi tradizionali e religiose con altre laiche, mise al bando i tribunali tribali e rese pubblica a tutti l’istruzione e la sanità, anche alle donne, che ne erano tenute fuori. Infine assunse anche alcuni provvedimenti “messaggio” come l’obbligo per gli uomini di tagliarsi la barba ed il divieto per le donne di indossare il burqa.

Quindi c’è stato un tentativo di modernizzazione vero, solido, dall’interno, basato sulle forze reali di una “avanguardia”, si sarebbe detto una volta; una minoranza cioè, sottile, ma che era comunque il meglio e quanto di più avanzato avesse prodotto la società afgana. E, di fronte anche alle contraddizioni interne che ne hanno travagliato il cammino c’era poco da farsi puzzare il naso: le rivoluzioni – mi dispiace per chi ha il puzzo ce l’ha – non sono un pranzo di gala, grondano di lacrime e sangue e purtroppo mangiano anche i propri figli, con la ghigliottina o i plotoni di esecuzione, e spesso non i peggiori…
Una minoranza solo sorretta dalla convinzione di marciare nel senso della storia migliore, una avanguardia dal sapore vagamente giacobino, che, per molti versi, richiama il ricordo a noi caro dei giacobini napoletani del ’99, anche essi “separati” dalle masse sterminate dei lazzari di Napoli e dei contadini abbrutiti dalla miseria e irretiti dai preti delle province meridionali. Una avanguardia generosa, di cui voglio citare almeno Mohammad Najibullah, ultimo Presidente: non scappò da Kabul, e, catturato in un palazzo ONU, fu evirato, legato dietro una jeep e quindi finito con una pallottola dai giustizieri talebani. A questi martiri non è spettato neppure il rimpianto postumo che non era almeno mancato a quelli delle forche borboniche di piazza Mercato a Napoli…
Per vincere, la rivoluzione avrebbe avuto bisogno che lo sforzo immane di quella avanguardia non fosse stato affogato nell’isolamento, ma che avesse potuto godere di una solidarietà vera, almeno dell’opinione pubblica democratica internazionale…
Ma ciò non avvenne: impose le sue ferree esigenze la cosiddetta “teoria del domino”, la paura di una penetrazione progressiva del comunismo sullo scacchiere asiatico e portò la dirigenza USA, anche dopo la sconfitta del Vietnam, ad una politica di contenimento anche a costo di scommettere sulle forze più retrive delle aree interessate.
La politica americana e quella dei suoi alleati restò imbrigliata nella logica di una seconda e tardiva “guerra fredda”, motivata con giustificazione postuma dal successivo intervento militare sovietico.
Ma questo è solo successivo alla scelte americane di sostegno alla contro-rivoluzione e, probabilmente, fu da esse sollecitato[i]. L’America non fu mossa, quindi, da un “obbligo di deterrenza” verso l’armata rossa avanzante ma dal vizio originale della sua politica di guerra fredda di stare con chiunque -i ceti più reazionari, i dittatori più sanguinari- purché questi fossero schierati contro i “comunisti”.
Essa scese in campo subito, col sostegno in armi e finanziamenti ai nemici dei “riformatori di Kabul”, intervento attivato ben prima dell’intervento sovietico, attraverso una decisione del “più democratico” dei Presidenti americani, Jimmy Carter, quasi sulla base di un riflesso condizionato come il toro che carica alla vista del fazzoletto rosso, e in piena continuità con la peggiore politica americana da Truman in avanti.
Gli americani, come gli inglesi di Nelson verso la Repubblica Napoletana, costruirono la resistenza al rinnovamento, alla modernità, facendo leva sugli istinti più bassi e conservativi della società afgana. Come gli inglesi di fine Settecento avevano messo in campo una armata di lazzari e cafoni sollevata dalle prediche oscurantiste di un clero reazionario e ignorante, così i servizi segreti Usa fecero leva sui mullah, il clero sunnita, che era l’unico vero cemento di una società arretrata ed incolta, e si ritrovarono, nel ruolo a Napoli assolto dal Cardinale Ruffo, il Mullah Omar ed il suo consigliere politico Osama Bin Laden.
La strategia la si fondò non solo su armi e finanziamenti per le milizie. Questo fu solo un aspetto, e non il più rilevante. Il fulcro ne fu l’identificazione dei mullah come gli interlocutori privilegiati a cui furono assicurati soldi a palate per costruire una rete diffusa di “scuole coraniche” finalizzate ad indottrinare la gioventù, e poi ancora soldi per mettere in piedi un solido apparato assistenziale che consentisse la “tenuta” della parte non combattente, e soldi per un sofisticato sistema di propaganda ed infine chiudendo gli entrambi gli occhi sui traffici di droga che alimentavano per i partito dei mullah altre copiose fonti di finanziamento.
Con i dollari americani, quelli delle retrive monarchie sunnite del Golfo Persico e quelli dell’oppio si poté finanziare la costruzione di un esercito ben armato; ma soprattutto coeso in quanto basato su un processo di promozione e selezione, in patria o nei campi profughi pakistani, di una parte della società afgana, i talebani, -studenti delle scuole coraniche- ideologizzata e preparata per candidarsi alla direzione dell’Afghanistan.
A questo gruppo fu fornita una identità del tutto nuova, con la rottura degli schemi tribali, fondata sulla interpretazione integralista del Corano. E di essi ne fecero dei mujaheddin, combattenti impegnati nel “jihād”, la guerra santa. Solo che gli americani non valutarono che la guerra santa è tale non solo se combattuta contro i “blasfemi rinnegati comunisti” di Kabul o gli invasori russi, è santa ogni volta è mossa contro tutto ciò è figlio, che appartiene alla civiltà contemporanea come la intendiamo alla luce della cultura occidentale, perché è guerra cieca contro il “diverso”, contro chi non è mussulmano.
I talebani non nascono dal nulla: hanno una madre, un seno entro cui sono generati, il sostrato di cultura islamica propria di un paese tribale, arretrato, agro-pastorale; ma hanno anche un padre, la scellerata politica americana, che sceglie l’arretratezza religiosa come l’humus con cui alimentare l’opposizione ad un Afghanistan rivoluzionario; ed ha infine come padrini l’opinione pubblica dei paesi occidentali, quella che volle scambiare una resistenza fondata sulla reazionaria difesa dello status quo e dell’arretratezza culturale come una “resistenza nazionale” al russo-straniero-invasore.

Ma è la vittoria di Khomeyni in Iran, a farne una miscela dirompente con l’aggiungervi nel ’79 il virus dell’integralismo, della “guerra santa”, della contrapposizione insanabile ai valori del mondo occidentale, del ritorno al “califfato” come la strada maestra per il recupero della dignità e del ruolo perduto da secoli dei popoli mussulmani, il virus del terrorismo. La miscela era pronta: la miccia accesa furono gli aiuti americani ai talebani.
Gli Usa sono stati un “apprendista stregone”: hanno evocato dalla profondità della storia fantasmi che erano seppelliti da secoli; lo hanno fatto con l’arroganza culturale di chi immaginava di poter gestire e governare ogni processo. Non era così; non è stato così.
La domanda che nessuno volle porsi allora e nessuno si pone oggi, è se – seppure con i “se” non si costruisce la storia – l’abbraccio soffocante con URSS di Breznev si sarebbe potuto evitare con la discesa in campo a sostegno delle ragioni dei rivoluzionari di Kabul in America, in Asia, in Europa di una solidarietà reale a chi voleva avanzare sulla strada maestra della civiltà.
Era chiaro, ma non lo si volle vedere che non si trattasse di una “rivoluzione importata” ma che questa avesse radici solide anche se minoritarie. Lo dimostra inoppugnabilmente il dato che la Repubblica Democratica Afghana non cadde dopo 15 giorni dal ritiro delle truppe russe, come è avvenuto oggi con il ritiro americano -o 35 giorni dopo il ritiro francese come avvenne per la Repubblica napoletana-: la Repubblica Democratica Afghana resistette con le sue sole forze dal febbraio 1989, quando l’ultimo soldato sovietico lascia il Paese, all’aprile del ’92. Per più di tre anni oppone ai talebani una eroica resistenza contendendogli il terreno centimetro per centimetro dopo avergli inflitto, solo con soldati suoi, afghani, una straordinaria sconfitta a Jalalabad.
L’Occidente in Afghanistan perse allora, quando fu incapace di trovare le strade per aiutare un processo di modernizzazione necessario, su qualunque strada e con qualunque forma si stesse tentando di portarlo avanti. L’America, e con esso l’Occidente intero, non solo è stato alla coda della storia, ma ne ha deviato il corso verso percorsi perigliosi ed oscuri.
Oggi lo tocchiamo con mano.
Ma se nessuno cerca le cause più lontane è perché qui, tutti, consapevoli o inconsapevoli, ne fummo complici.
[i] Si riporta, così come citata da Giulietto Chiesa nel suo libro “La Guerra Infinita” Zanichelli 2002:
“…Leggiamo insieme, in versione integrale, l‘intervista che Zbignew Brzezinski rilasciò a Le Nouvel Observateur nel 1998.
Domanda: l’attuale presidente della Cia, Robert Gates. constata nelle sue memorie (Dalle Ombre) che i servizi segreti degli Stati Uniti cominciarono ad aiutare i mujaheddin in Afghanistan sei mesi prima dell’intervento sovietico. ln quel periodo lei era consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Carter. Dev’esserci dunque stato un suo intervento nella questione. È corretto?
Risposta: Sì. Secondo la storia ufficiale gli aiuti della Cia ai mujaheddin cominciarono nel corso del 1980, vale a dire dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan del 24 dicembre 1979. Ma la verità, tenuta segreta fino a questo momento, è completamente diversa: infatti la prima direttiva per aiuti segreti agli oppositori del regime filo-sovietico di Kabul fu firmata dal presidente Carter il 3 luglio 1979. Quello stesso giorno scrissi una nota al presidente nella quale spiegavo che secondo me quegli aiuti avrebbero indotto i sovietici all’intervento militare.
Domanda: Consapevole del rischio, lei fu un sostenitore di quella covert action. Speravate forse che l’Unione Sovietica intervenisse e avete lavorato per provocarne l’intervento?
Risposta: Non è esattamente così. Noi non abbiamo spinto l’Unione Sovietica a intervenire, ma abbiamo consapevolmente fatto aumentare la probabilità di un suo intervento.
Domanda: Quando i sovietici giustificarono il loro intervento asserendo che intendevano contrastare un coinvolgimento segreto degli Stati Uniti in Afghanistan, nessuno diede loro credito. Non era poi così lontano dal vero. Non avete nessun rimorso ora?
Risposta: Rimorso per cosa? Quell’operazione segreta è stata un‘ottima idea. Ebbe l’effetto di trascinare i sovietici nella trappola afghana…”