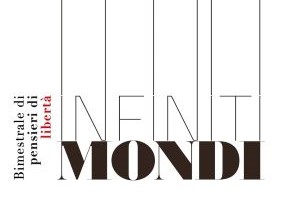di Silvio Greco
Sono passati 7 mesi da quando, con l’inizio del il lockdown, tante nuove e profonde riflessioni sono entrate nella vita quotidiana di tanti, inclusi tanti politici – almeno così ci sembrava –.
Come il virus è arrivato tra noi, quale spillover lo abbia portato ad infettare l’uomo, se il pangolino o il pipistrello, se i wet market cinesi o la deforestazione sono temi importanti, ma non dirimenti: il virus ora è qui con noi e dobbiamo gestirlo, imparare a convivere con lui e con i suoi simili che arriveranno, lo sappiamo per certo, in futuro.
Un virus, una “particella infettiva di dimensioni submicroscopiche”, come da definizione ufficiale, che non è in grado di sopravvivere autonomamente (e per questo motivo non viene definito come organismo vivente) ma solo parassitando cellule altrui, ha messo sotto i riflettori non solo e non tanto le nostre fragilità costitutive, ma soprattutto le controindicazioni di un modello di sviluppo che ci ha portato a preparare la situazione ideale per il suo sviluppo.
Provo qui a riassumerle brevemente, per grandi settori:
– le grandi metropoli. I luoghi in cui diversi milioni di persone vivono affollando quotidianamente le strade, i mezzi pubblici, i locali, sono perfetti: offrono al virus ua sterminata quantità di cellule che gli possono consentire – virtualmente – l’immortalità;
– Il nostro stile di vita. Se queste grandi metropoli sono popolate da persone stressate, i cui sistemi immunitari nemmeno ricordano più quali meravigliosi meccanismi di difesa potrebbero essere, poiché i loro proprietari si cibano prevalentemente con alimenti altamente industrializzati e raffinati, ricchi di zuccheri, grassi e sale, riducendo il loro microbiota a un deserto, allora il virus ha non solo la scelta, ma anche delle autostrade a disposizione per viaggiare indisturbato e velocissimo da un individuo all’altro;
– L’agricoltura industriale. Quella modalità di produzione agricola che si comporta con la terra, l’aria e l’acqua esattamente come noi ci comportiamo con il nostro intestino, ha contribuito non solo producendo gli alimenti di cui al punto precedente, ma anche eliminando difese naturali, annullando biodiversità, inserendo nel sistema ecologico sostanze che non sono metabolizzabili, utilizzando metodologie di lavoro che non tengono conto della sanità delle risorse e contribuendo a popolare l’aria che respiriamo di particelle che non solo la rendono sostanzialmente tossica, ma funzionano come eccellenti taxi per aiutare il virus a compiere spostamenti che diversamente non potrebbe come fare;
– l’industria non agricola ha contribuito per quel che concerne la sua parte, nel danneggiamento sia del sistema delle acque sia di quello dell’aria e del suolo;
– noi cittadini, con i nostri traporti privati (ma d’altronde quelli pubblici spesso non esistono oppure o sono di scarsa qualità, o semplicemente non sono sufficienti in termini quantitativi) non ci siamo tirati indietro e abbiamo alacremente contribuito ai preparativi di accoglienza del virus.
Non dimentico, in questa lista, la questione climatica, ma non la inserisco in queso elenco perché è semplicemente la risultante di tutti i comportamenti a rischio che ho elencato. Sì, comportamenti a rischio: come fare sesso non protetto con sconosciuti o come sparare a casaccio tra la folla. Ma dal momento che – come Greta Thunberg ripete inutilmente da due anni circa – la nostra percezione del rischio non si attiva se i danni si presentano lentamente e gradualmente, ecco che continuiamo a comportarci da incoscienti e nessuno cerca di impedircelo. Anzi, parafrasando Tacito, abbiamo creato una bomba ad orologeria e lo abbiamo chiamato sviluppo.
Non c’era alternativa al lockdown: in una situazione in cui tutti i nostri gesti quotidiani erano ideali per favorire il virus (inclusi i gesti di cortesia come le strette di mano, quelli casuali come il bere dalla medesima bottiglia di birra, fino alle brutte abitudini di parlare avvicinandosi vieppiù all’interlocutore o di andare al lavoro anche in presenza di raffreddori e costipazioni evidenti), nell’emergenza l’unica via di scampo era interrompere quei gesti, impedire al virus di trovare così tante occasioni di colonizzazione, bruciare i ponti.
I risultati non si sono fatti attendere, non solo per quel che riguarda la pandemia, ma anche per tutti i settori menzionati sopra: tra lo stupore e la soddisfazione generale, in ogni angolo del globo l’aria si è fatta più pulita, i mari più popolati (di pesci), abbiamo finalmente sentito cantare gli uccelli nelle nostre città e le fioriture primaverili ci sono sembrate prodigiose. Secondo alcuni studi si sono evitate, nelle principali città del mondo, circa 12mila morti per malattie correlate all’inquinamento atmosferico, durante quel periodo (buone notizie sì, ma non c’è da cantar vittoria: nella sola Europa si contano circa 400mila morti precoci all’anno per queste cause).
Tuttavia non c’era nessuno prodigio in corso e non era difficile da capire: non eravamo diventati più rispettosi della natura né meno inquinanti nelle produzioni. Semplicemente se tutto è bloccato, non inquinare diventa la conseguenza più logica. Quello che avremmo dovuto fare è porre il rispetto dell’ambiente come obiettivo della produzione, ma non lo abbiamo fatto. Tanto è vero che appena tutto si è rimesso in moto la situazione è rapidamente tornata al punto di partenza, anzi è peggiorata un po’ perché l’ansia di “recuperare” il tempo, il denaro e la produzione persi si è trasformata in una impronta ecologica ancora più pesante.
Non solo: dato che non è stato usato il lockdown per ripensare e migliorare i trasporti pubblici, molti alla ripresa hanno preferito l’automobile, e ancora lo stanno facendo, sicché una parte di coloro che prima usava in serenità metropolitane, bus e treni, oggi preferisce spendere qualcosa in più e usare le automobili private: la sicurezza innanzitutto, si dicono, ed è difficile dar loro torto. Ma la sicurezza di chi, e per quanto?
Gli studi sopra citati (ad esempio quelli del Centre for research on energy and clean air) ci dicono anche che già all’inizio di settembre nelle città monitorate (le grandi metropoli) i livelli di inquinamento erano tornati ai tassi pre-lockdown. Non possiamo, onestamente, sorprendercene, sappiamo bene che sperare di ottenere risultati diversi ripetendo le medesime azioni è una delle manifestazioni della malattia mentale. Forse è proprio su questo che dovremmo riflettere, su questa specie di follia che si è in qualche modo imposta e che ci porta a proporre e progettare sempre l’esatto contrario di quello che i dati e i fatti ci suggeriscono.
Ne è un esempio lampante il caso della plastica: all’inizio dell’anno avevamo una legge in itinere, che prevedeva un aumento degli oneri produttivi per i produttori di plastica monouso. Tra i primissimi pensieri balenati a tanti nostri politici nella fase di emergenza c’è stato quello di bloccare quell’iter, rimandare, soprassedere. Con il plauso, ovviamente dei produttori, che hanno trasformato le legittime preoccupazioni per l’igiene di ogni cittadino in un’ondata anomala di oggetti monouso. Quanti si stavano, in era pre-Covid, adoperando per eliminare il monouso superfluo (bicchieri, cannucce, posate, piatti) o quantomeno per sostituirlo con materiali meno impattanti hanno visto i propri sforzi ridicolizzati dal moltiplicarsi di nuove situazioni in cui la plastica era non solo tollerata, ma addirittura incoraggiata. Ricorderete la fase di parziale riapertura, quando i bar si potevano frequentare, ma senza entrarci e facendosi servire il caffè all’aperto, in piedi, sulla soglia o davanti alle finestrelle dalle quali siamo soliti ricevere i gelati da passeggio. Un’occhiata ai cestini in vicinanza di quei bar raccontava molto della totale sconnessione tra le cose che sappiamo (l’inquinamento favorisce i virus) e quelle che facciamo.
L’amaro capitolo dei cosiddetti DPI, i dispositivi di protezione individuale, è poi la conferma che non abbiamo davvero imparato nulla. Mascherine chirurgiche e guanti monouso popolano ormai tutti i marciapiedi, le aiuole e i cigli delle nostre strade. E questa è la migliore delle ipotesi perché da là qualcuno, volendo, può raccoglierli e conferirli con i rifiuti indifferenziati: possono farlo i netturbini, o i cittadini di buona volontà (che fortunatamente sono sempre più numerosi) che escono a passeggiare armati di sacchetti e raccolgono quello che i cittadini di pessima volontà lasciano in giro: fino a qualche mese fa erano prevalentemente pacchetti di sigarette vuoti, lattine, volantini dei supermercati (quando verrà regolarizzata quest’altra follia?), tetrapak dei succhi di frutta con relativa cannuccia di plastica. Ma c’è un posto in cui i cittadini di buona volontà non possono passare e i netturbini non sono previsti: il mare. I mari e gli oceani, ai quali non mancava nulla del campionario di immondizia che siamo in grado di produrre a terra, dalle vernici ai copertoni, e che stanno letteralmente soffocando nella plastica (la stessa che ormai ci mangiamo regolarmente al ritmo di circa 5 grammi alla settimana) si stanno popolando anche di questi nuovi rifiuti, con ritmi e tonnellaggi insostenibili.
Il panorama, insomma, è desolante. Dunque, che si fa? Rinunciamo alla lotta e attendiamo la prossima apocalisse?
Qualcuno, effettivamente, spinge in questa direzione, perché le apocalissi dei giorni nostri non sono come quelle bibliche, totali e universali. Le apocalissi contemporanee sono sempre parziali. E se sono parziali vuol dire che mentre qualcuno soccombe e perde tutto, vita compresa, c’è sempre qualcuno che, almeno temporaneamente, ci guadagna.
Tuttavia qualche segnale di speranza arriva, e arriva da dove, distratte dal baccano populista, molte persone non se la sarebbero aspettata. Per esempio, l’Unione Europea. Il Green New Deal, con le relative strategie (legate al cibo, alla biodiversità, alle aree rurali…) può rappresentare, nel nostro continente ma non solo, un importante punto di svolta. Ingenti investimenti sono previsti a favore di un diverso modo di produrre beni ed energia, di organizzare le città, di gestire i trasporti, di indirizzare la ricerca. Una quantità significativa di fondi viene messa a disposizione del bene comune, finalizzata alla sostenibilità ambientale. L’unica cosa che dobbiamo fare è non sprecarla. Perché difficilmente – se questa volta falliamo – avremo una seconda opportunità.
Ora, per evitare il fallimento del Green Deal servono soprattutto due cose: competenze e coerenza.
Competenze profonde e dettagliate, che si interconnettano e sappiano fare sistema, in una visione complessa che prenda in via definitiva il posto del riduzionismo che ha caratterizzato finora troppa produzione e troppa azione politica ed economica. Coerenza perché mettere fondi a disposizione di un diverso modello di sviluppo deve anche significane togliere finanziamenti e supporto politico e normativo alle attività che invece intendono continuare sulle orme di un modello ormai non solo obsoleto e antieconomico ma che ha ampiamente dimostrato di essere dannoso.
Realizzare il Green New Deal non può significare che da qui in avanti si potrà scegliere se produrre, comprare e vendere nel rispetto della sostenibilità o continuare a non farlo avendo comunque piena cittadinanza e pieno supporto. Realizzare il Green New Deal richiede un ripensamento radicale, la messa in opera di quei “nuovi paradigmi” di cui sentiamo parlare da almeno 30 anni.
Realizzare il Green New Deal significa ribaltare, sradicare – a cominciare dalle scuole primarie – alcuni convincimenti che tanto comodo hanno fatto a certa politica e a certa economia: per esempio l’idea che si debba scegliere tra sostenibilità e competitività; per esempio che se proprio si sceglie la sostenibilità allora prima deve venire quella economica; per esempio che se si sceglie di proteggere l’ambiente, allora bisogna sacrificare posti di lavoro. E dunque bisogna scegliere: o si crea lavoro o si protegge la salute pubblica; o si crea lavoro o si evita di ridurre il mondo ad un grande immondezzaio di oggetti inutili. Serve un’ondata di politici, di economisti, di produttori, di insegnanti e di intellettuali che sappiano diffondere le competenze ecologiche scardinando quelle idee, che ormai hanno dato prova di tutta la loro tossicità ecologica, economica, sociale e culturale.
Mai come oggi ci sono state, a disposizione di politici, industriali, produttori, associazioni di categoria e privati cittadini tante raffinate e solide competenze. La schiera di quanti possono contribuire a costruire un domani diverso è lunghissima: sono coloro grazie ai quali lo studio dell’ecologia non è andato perduto; grazie ai quali in alcune zone del continente ci sono esperimenti straordinariamente interessanti per quel che riguarda la produzione, l’istruzione, l’organizzazione sociale; grazie ai quali ci sono paesi – per esempio l’Italia – con percentuali di produzione biologica già vicine alla media che l’Unione Europea si è posta come obiettivo per il 2030; grazie ai quali si sono costituiti movimenti, reti e associazioni che hanno lasciato e continuano a lasciare una impronta culturale profonda e benefica nei paesi in cui operano. Sono persone che per la prima volta nella loro vita – politica, professionale, sociale – sentono di avere al loro fianco almeno le istituzioni sovranazionali. Riusciranno le politiche dei paesi membri a non vanificare tutti questi sforzi e ad usare correttamente questo straordinario patrimonio? Non basta sperare di sì, occorre sostenere chi lo farà e denunciare chi remerà contro.