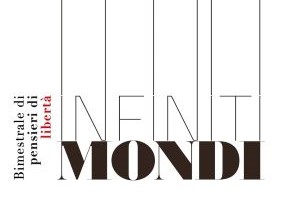di Ugo Leone
Da quando la commissione Brundtland ne coniò la definizione ad oggi sono passati 33 anni e l’aggettivo sostenibile del quale si è fatto un sostanziale abuso, ha progressivamente perso il significato che quella commissione gli aveva dato e ha progressivamente recuperato il suo originario significato.
Il rapporto Brundtland (dal nome della coordinatrice Gro Harlem Brundtland, noto come Our Common Future) è un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Così inteso: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».
Quale era, invece, in Italiano, l’originario significato di quell’aggettivo? Ce lo dice, tra gli altri, il Dizionario di Italiano Hoepli: sostenibile: 1 Che si può sostenere, sorreggere; 2 fig. Tollerabile, sopportabile: ormai la situazione non era più s. Fine modulo CONT. Insostenibile; 3 fig. Che si può affermare con convinzione: opinioni sostenibili.
Allora proviamo ad uscire dalla definizione (ma non dal concetto) della Brundtland; cerchiamo di affrontare il problema economico, sociale, ambientale inserendolo nel presente contesto planetario e proviamo a chiederci se tutto quanto accade e si ipotizza che accadrà in futuro sia sopportabile, tollerabile.
Non so dire quanto si possa considerare “sostenibile” questo mio approccio e le risposte che provo a dare, ma mi pare che guardandoci intorno e gettando un occhio al futuro la situazione non sia sopportabile. E mi sembra che intollerabili siano i comportamenti che l’hanno generata e che ne ostacolano ogni tentativo di miglioramento. Perché quelli che potrebbero intervenire considerano questi tentativi tali da compromettere i propri immediati interessi economici e politici.
Naturalmente non mi riferisco alla pandemia in corso ormai da dieci mesi, ma alla più grave pandemia climatica il cui progressivo e sempre più rapido e incalzante mutamento compromette la presente e, ancor più, la futura qualità della vita.
È questa una pandemia che ci costringe a prendere atto che la Terra da anni ha intrapreso una strada di pericoloso non ritorno provocato da comportamenti insipienti, irrispettosi, egoisti di gran parte del genere umano. Se è così dobbiamo chiederci se sia realisticamente possibile impedire il rischio che si vada incontro ad una sesta estinzione di massa. Se, cioè, sia realistico e non utopistico lasciare a chi verrà dopo di noi una Terra vivibile nel migliore dei modi possibile. E per tutti e non solo per i sopravvissuti.
Questo mi sembra il contesto, le parole e i concetti chiave dai quali partire per affrontare il problema nel modo più scientificamente accettabile. Chiedendoci con Jonathan Safran Foer se Possiamo salvare il mondo prima di cena (Guanda 2019). Realisticamente sì. È la risposta se ci rendiamo conto come suggerisce il sottotitolo di questo libro, che il clima siamo noi. Né solo il clima. Come avverte Telmo Pievani nella recensione che ne ha fatto per “la lettura” (Tutti a dieta. Maglio vegetariani che morti, 1 settembre 2019) “la casa è in fiamme, ma non abbiamo ancora compreso davvero che è la nostra casa a essere in fiamme. Sappiamo di essere in guerra, ma non sentiamo il rumore della battaglia”.
I mutamenti climatici, vale a dire l’incremento di quelli che vengono definiti eventi estremi e la catena di conseguenze legate all’aumento delle temperature (scioglimento dei ghiacciai polari e innalzamento del livello degli oceani), sono la più ricorrente causa di preoccupazioni.
Tutto questo si aggiunge, comunque, ad una serie di altri rischi legati ad eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, …) che sono tanto più calamitosi in quanto la Terra diventa sempre più vulnerabile non solo in seguito all’aumento della sua popolazione, ma ancor più per il maltrattamento che se ne compie.
Un’impostazione di questo tipo lascerebbe intendere che non esistono speranze di salvezza e che effettivamente l’estinzione è dietro l’angolo. In realtà non è così, e non è solo un auspicio come dimostra la storia dell’evoluzione umana.
Mi sembra cioè realistico che, avendone le capacità e le disponibilità tecnologiche, se ne abbia anche la volontà. Che l’umanità, cioè, faccia prevalere il suo istinto di conservazione. Anche se, altrettanto realisticamente, bisogna prendere atto dei tempi non brevi per uscire dalle situazioni di rischio e pericolo, e, di conseguenza puntare non solo sulla resilienza dell’umanità, ma anche sul suo adattamento a situazioni con le quali per quanto difficili –comunque differenti- è possibile convivere.
Ma convivere in una Terra che non sarà più la stessa. Perché non mi sembra immaginabile che torni allo stato in cui era (la resilienza), e le modifiche che vi saranno richiederanno un possibile, necessario e non drammatico, adattamento. Non tutti se lo potranno consentire e se mai si dovesse registrare la temuta estinzione del genere umano, questa riguarderà i più poveri, deboli ed emarginati.
Inoltre, realisticamente, se i calcoli sui risultati raggiunti si faranno a fine secolo mentre si mettono in atto le azioni di prevenzione e mitigazione che cosa si fa “nel frattempo?”. È certo che la lenta modifica degli odierni modi di vita, di produrre, di consumare, di muoversi non porteranno al totale recupero della situazione com’era cinquanta e più anni prima. E questo provoca un progressivo adattamento ai modificandi ambienti di vita. Insomma le generazioni future vivranno su un pianeta diverso e questa diversità richiede un adattamento globale per vivere nel migliore dei modi possibile, nel migliore dei mondi possibile.
Facevo queste riflessioni il 1° settembre e mi accorsi che proprio quel giorno si celebra da oltre 30 anni: “La giornata per la custodia del creato” che per iniziativa della Conferenza Episcopale italiana.
Tra il susseguirsi, senza rispetto della “tradizione climatica”, di eventi estremi quali bombe d’acqua, esondazioni di fiumi (Isarco e Adige gli ultimi), grandinate che compromettono i raccolti, venti violenti che provocano la caduta di alberi uccidendo due povere bambine; tra il susseguirsi di tutto questo e le impennate dei contagi da coronavirus, c’è proprio da chiedersi –fede a parte- che cosa ci rimanga da custodire. E, più ancora, chi sono i custodi?
Dicevo fede a parte perché come ha scritto Bernard Haring, “Chi pecca in continuazione e irresponsabilmente contro il nostro pianeta e contro la vita presente su di esso, corre il gravissimo pericolo di rendersi indegno e incapace del paradiso eterno”
Naturalmente per “creato” si intende la Terra con i suoi quasi otto miliardi di abitanti. Ma proviamo a riflettere sulla casa nostra Italia.
Come ha scritto Giacomo Talignani su “la Repubblica” del 31 agosto 2020 (Correnti estive mai viste. E nell’Italia tropicale i temporali sono cicloni): “Con le correnti che cambiano, il mare che si surriscalda e senza più protezione dell’anticiclone delle Azzorre, l’Italia si trasforma in un pungiball preso a pugni dagli effetti della crisi climatica.” I pugni più potenti per ricevere i quali non siamo preparati, vengono dall’anticiclone africano. Quello che, come nota Antonello Pasini, tra i maggiori esperti di clima, quando “va giù e torna su dall’Africa non entra più l’anticiclone delle Azzorre a difenderci come prima, ma entrano subito correnti fredde da nord”. Le quali sono le responsabili degli eventi estremi che prima ricordavo. Non solo. Perché estati lunghe, calde e instabili come quelle che viviamo da qualche anno, provocano anche il riscaldamento del mare- per cui c’è da attendersi un autunno probabilmente più caldo e piovoso con “fenomeni meteo violenti e distruttivi”.
Così stanno le cose e fino a quando i custodi del creato -molti dei quali ritengono di avere altro cui pensare- non riusciranno a rallentare queste tendenze, sarà questa una condizione cui dovremo abituarci.
Non abituarci a morire in un mare di fango o sotto un albero buttato giù dal vento, ma attrezzarci a preparare le difese.
L’Italia è già di per sé un Paese fragile e soggetto lungo tutto l’Appennino a forte dissesto idrogeologico con alluvioni, frane e smottamenti. E, sul versante costiero, con molti tratti di spiagge soggette ad erosione costiera.
Il mutamento climatico in atto di conseguenza, avverte Pasini,
“con un clima che tende a una tropicalizzazione e un territorio fragile già devastato da sfruttamento del suolo, abusivismo e infrastrutture inadeguate” può ulteriormente sconvolgere il territorio.
Con queste prospettive la custodia sta essenzialmente nella prevenzione agendo sulla vulnerabilità del territorio “costruendo opere idrauliche e migliorando le condizioni, ad esempio di fiumi tombati e aree soggette ad abusivismo”.
Insomma bisogna adattarsi al cambio climatico in atto. Non esistono più le mezze stagioni, è stato per anni un ritornello di schetch comici. È così. Ma, peggio, non si sa più le stagioni di cosa sono fatte e per prevenirne la conseguenze negative i custodi del territorio, che sono gli amministratori della cosa pubblica, devono creare le condizioni per una difesa sicura di ambiente, territorio e di chi ci vive.
Il territorio. Questa è un’altra delle parole usate pigramente senza darvi il significato che meritano. Allora vale la pena di riflettere e di ricordare che il territorio non è qualcosa su cui mettere i piedi e, quindi, anche da calpestare nella più ampia accezione del termine. Il territorio, invece, come ha sempre sottolineato Lucio Gambi, non è una realtà esclusivamente fisica, ma è la componente di una stretta connessione con sviluppo, società insediate, storia, tradizioni e impegno politico e organizzativo delle società stesse. E in un Paese come l’Italia nel quale è una componente fisica di rilevante estensione, è la vita stessa del paese..
L’indifferenza politica che ha storicamente caratterizzato la necessaria custodia di questo importante patrimonio naturale e che in Italia è prevalentemente l’Appennino, ha provocato il progressivo abbandono dei territori montani e collinari che, privati della presenza umana, cioè dei loro custodi, si sono ulteriormente indeboliti e diventati ancor più oggetto degli eventi del dissesto idrogeologico.
Allora volendo tornare alla custodia e ai custodi, venendo meno i custodi istituzionali bisognerebbe identificare i reali custodi nei residui abitanti di queste aree prima che lo spopolamento le renda ancora più marginali nei modi di intendere le politiche di sviluppo economico. Significa che, come sosteneva già una cinquantina di anni fa Marcello Vittorini, chi ancora è radicato in questi luoghi sia individuato come “carabiniere” per la loro tutela con il riconoscimento di un adeguato salario part time per il compito che svolgono. Salario e compito che a queste condizioni potrebbero essere anche tali da provocare il rientro di non pochi dei “fuorusciti”. È sostenibile tutto questo? Deve esserlo e in tutti i significati che vogliamo dare a questo aggettivo. Anche perché è intollerabile che non si agisca per evitare la distruzione, l’autodistruzione, di un pianeta che siamo chiamati a custodire.