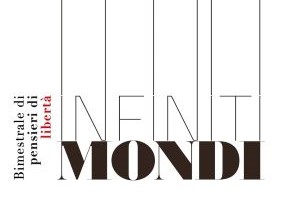Prosegue il dibattito aperto da Infinitimondi. Si avvicina l’Assemblea del 4 settembre promossa da Democratici per l’Alternativa che vedrà l’intervento conclusivo di Gianni Cuperlo. In ragione delle scelte più recenti del PD nel confronto tra Napoli e Roma è sempre più evidente che un semplice proporsi di questa area ampia e significativa di militanti della sinistra come semplice componente/corrente interna al PD ne metterebbe in discussione molto del possibile positivo ruolo. Si vedrà il 4. Intanto oggi ospitiamo altre riflessioni importanti: di Vittorio Mazzone, figura storica della sinistra dell’Area a Nord di Napoli, del Circolo Città Futura di Cercola, di Francesco Miragliuolo, giovane studioso.
DA RIGENERA CAMPANIA UNA INDICAZIONE PER RIGENERARE LA POLITICA
di Vittorio Mazzone
Considero di grande valore strategico la bella esperienza di Rigenera, che , nei fatti, sta affermando un nuovo modo di fare politica.
Nel vuoto lacerante della fase storica che stiamo vivendo, è stata davvero lungimirante la scelta di chiamare al confronto, su un tema così dirimente come quello dell’ambiente e della sua tutela, singoli cittadini, associazioni e studiosi al fine di redigere insieme una proposta di legge popolare da proporre alla discussione e all’approvazione nel Consiglio regionale della Campania.
Il solo fatto di aver promosso un ampio confronto di merito su un tema così decisivo per il futuro della qualità della vita nella nostra Regione è da prendere ad esempio, anche perché, dopo la fase iniziale del libero confronto, si è realizzato un lavoro di scrittura a più mani di una proposta di legge che è stata sottoscritta da oltre 10.000 cittadini campani.
In questo modo si è riconosciuto nuovamente valore all’impegno sociale, culturale e civile, rimotivando tanti militanti delusi dalle chiusure burocratiche e dalle ossificazioni, che caratterizzano attualmente la vita dei Partiti a livello locale e nazionale.
Per questi motivi è necessario che l’esperienza di Rigenera si moltiplichi sollecitando l’attenzione su altre tematiche di eguale rilevanza sociale.
Penso, in particolare che sia importante promuovere nuovi processi di partecipazione democratica su altre grandi questioni , come quelle della sanità pubblica e della scuola pubblica, le cui disfunzioni pesano decisamente sulla vita di noi tutti.
Su un altro grande tema, poi, occorre promuovere un’accurata riflessione di massa. Mi riferisco al disagio giovanile, che, sempre più di frequente, è all’origine dei fenomeni di vera e propria criminalità, di cui ci lamentiamo senza comprenderne le radici di fondo e, di conseguenza, senza far nulla per rimuoverle.
In buona sostanza, ritengo che sia urgente impegnarsi per promuovere una vera e propria RIVOLUZIONE CULTURALE, MORALE E CIVILE, che abbia come punti ineludibili di riferimento i valori ideali della Resistenza antifascista e il dettato della nostra Carta costituzionale da attuare pienamente, a partire dal secondo comma dell’articolo 3, del tutto disatteso, che richiama all’uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini.
Naturalmente, so bene che per realizzare le cose che propongo occorre un lavoro di lunga lena, come si diceva una volta, ed, intanto, occorre fare i conti con le urgenze della politica, a partire dalle imminenti elezioni regionali.
A proposito delle due opzioni proposte da Gianfranco Nappi, devo dire che escludo quella di legarsi ad un Partito e ritengo difficilmente praticabile l’idea di prevedere la presenza di un’area alternativa all’interno della coalizione di centrosinistra.
E’ necessario, invece, che Rigenera promuova una discussione di merito, aprendosi al confronto pubblico con tutte le realtà culturali, sociali e politiche che per la propria storia e la vicinanza ideale potrebbero far parte di un NUCLEO PER L’ALTERNATIVA.
L’obiettivo è quello di concordare alcuni punti programmatici fondamentali e verificare la disponibilità della coalizione anti destra ad accoglierli nel proprio programma di governo per la Regione Campania.
Se ciò dovesse avvenire, i soggetti che compongono questo NUCLEO PER L’ALTERNATIVA potrebbero dar vita ad una o più liste collegate alla coalizione antidestra.
E’ evidente che tutto si complicherebbe se si dovesse verificare la chiusura delle forze politiche che compongono la coalizione antidestra, che potrebbero cullarsi fidando sul “richiamo al voto utile” di perniciosa veltroniana memoria.
Voglio sperare che ciò non accada perché, naturalmente, si rischierebbe davvero di regalare alle destre il governo della nostra Regione.
A questo punto, vorrei dire alle forze politiche della coalizione antidestra che il cosiddetto ”voto utile” se lo devono guadagnare se vogliono contrastare efficacemente il fenomeno dell’astensionismo, che certamente danneggerebbe tutti e, in primo luogo, la nostra democrazia.
***
UNA SFIDA DA ACCETTARE E RILANCIARE
Circolo Città Futura di Cercola
27-AGOSTO-2025-DA-CERCOLASU-REGIONALI***
DAL PARTITO LIQUIDO AL PARTITO NECESSARIO
di Francesco Miragliuolo
La recente vicenda campana, che richiama vecchie logiche di spartizione in perfetto stile manuale Cencelli, induce a riflettere sul ruolo che i partiti erano chiamati a svolgere secondo i padri costituenti e su come si sia poi giunti all’attuale involuzione della forma-partito. È infatti fondamentale comprendere in che modo oggi si sviluppino i processi di selezione della classe dirigente, spesso orientati più all’autoconservazione che alla valorizzazione di quadri meritevoli e motivati.
I PARTITI NELL’ITALIA LIBERALE E POST-UNITARIA
La nostra indagine non può che partire da lontano, così da comprendere appieno l’esperienza partitica italiana, maturata progressivamente nel nostro Paese e profondamente mutata nel corso delle diverse epoche storiche.
Nell’Italia post-unitaria vigeva un modello di legge elettorale a base estremamente ristretta, fondato quasi esclusivamente sulla classe borghese. Ne risultava uno Stato di fatto monoclasse, in cui i partiti si configuravano soprattutto come aggregazioni di notabili locali legati a figure di spicco a livello nazionale. In questo contesto il Parlamento finiva per essere composto da deputati “nominati”, più che realmente rappresentativi, e ciò rafforzava in misura significativa la posizione del governo rispetto a quella dell’assemblea parlamentare.
Un primo segnale di cambiamento giunse con la riforma elettorale del 1882, che abbassò il censo richiesto per il diritto di voto, ridusse l’età minima per l’elettorato attivo e ampliò così la base degli aventi diritto. Grazie a questa trasformazione entrò in Parlamento il primo deputato socialista, Andrea Costa, a testimonianza di un processo di progressiva inclusione politica. Perfino i contadini, i cosiddetti “cafoni”, cominciavano ad avere la possibilità di eleggere i propri rappresentanti. Questa evoluzione rispecchiava l’idea di Vittorio Emanuele Orlando secondo cui la rappresentanza non doveva essere un privilegio derivante dalla nascita o dalla posizione sociale, bensì un riconoscimento delle capacità individuali, attribuito dal corpo elettorale a chi fosse ritenuto realmente idoneo a svolgere la funzione pubblica.
LA RIFORMA ELETTORALE PROPORZIONALE E LE DIVERSE TESI
La nascita della Repubblica di Weimar rappresentò una novità significativa rispetto alla forma di Stato prevalente in quell’epoca, soprattutto perché il diritto non veniva più spiegato esclusivamente in base a se stesso, ma considerato dal punto di vista della sua funzione sociale. In questo quadro anche i partiti – sebbene non formalmente disciplinati nella Costituzione – assunsero un ruolo fondamentale di mediazione. Secondo le teorie di Kelsen, essi non dovevano essere intesi come soggetti di conflitto e di disgregazione dell’unità statale, bensì come organizzazioni in grado di favorire l’integrazione politica e la crescita democratica della società.
In Italia due eventi risultarono decisivi per lo sviluppo della forma-partito, oltre all’affermazione dei movimenti socialisti, successivamente sfociati anche nella tradizione comunista: la legge elettorale del 1912, che ampliò considerevolmente il corpo elettorale, e la legge proporzionale del 1919, che inaugurò un sistema di partiti a base popolare. Questo percorso condusse progressivamente alla nascita del partito di massa, di cui resta centrale la memoria togliattiana. Ne derivò una progressiva democratizzazione dello Stato, che si trasformò da Stato monoclasse a Stato pluriclasse.
Un rilievo particolare ebbero anche, per la nostra Assemblea costituente, le idee di Antonio Gramsci riguardo alla funzione del partito: non soltanto come strumento di rappresentanza, ma come soggetto in grado di organizzare il consenso, formare una coscienza collettiva e costruire un blocco storico capace di dirigere la società.
L’ASSEMBLEA COSTITUENTE E L’ARTICOLO 49
Enrico Grosso ha osservato che per lungo tempo la forma di governo parlamentare italiana non si è esaurita nel solo dettato costituzionale, ma si è retta anche su prassi condivise fra i partiti, le cosiddette convenzioni costituzionali, le quali hanno garantito l’operatività concreta del sistema. Tali convenzioni, espressione della cultura costituzionale e della responsabilità politica delle forze parlamentari, hanno supplito alla scelta dei costituenti di lasciare la forma di governo “aperta”, priva cioè di una tipizzazione rigida nei rapporti fra i poteri.
Questa impostazione rifletteva l’indirizzo maturato già nei lavori della I Sottocommissione dell’Assemblea costituente, dove il ruolo dei partiti fu oggetto di un ampio dibattito, orientato a superare definitivamente l’esperienza del partito unico del regime fascista e a chiarire i limiti e le modalità della loro partecipazione alla vita democratica, evitando ogni forma di identificazione tra partito e Stato. Fu in questo contesto che si giunse alla formulazione dell’attuale articolo 49 della Costituzione, il quale riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
L’inserimento del riferimento espresso al “metodo democratico” si deve a Lelio Basso, che lo considerava una clausola di garanzia costituzionale contro ogni possibile deriva autoritaria. Tale espressione assume una portata non meramente descrittiva, ma prescrittiva, vincolando i partiti al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
Il dibattito, tuttavia, non si fermò a questo punto. Costantino Mortati propose di introdurre un controllo sulla conformità dell’attività dei partiti ai principi costituzionali, persino attraverso il vaglio della Corte costituzionale: una proposta che non venne accolta, ma che testimonia la profondità del confronto.
Basso, nella sua relazione, arrivò a parlare di una vera e propria “democrazia dei partiti”, in cui le formazioni politiche assumono una funzione centrale nella mediazione tra cittadini e istituzioni, configurandosi come soggetti privati investiti di una funzione pubblicistica essenziale, in nome del pluralismo e della partecipazione popolare.
Le sue tesi trovarono l’appoggio di Aldo Moro e Palmiro Togliatti, che tuttavia sottolinearono l’opportunità di evitare una tipizzazione troppo rigida del ruolo dei partiti, ritenendo preferibile lasciare che fosse la prassi politica e istituzionale – la cosiddetta Costituzione materiale – a definirne concretamente le funzioni.
Di diverso avviso fu Costantino Sullo, che da una prospettiva liberale si oppose a qualunque forma di controllo giurisdizionale o statale sui partiti, temendo il rischio di una “giustizia politica” incompatibile con il pluralismo democratico. Sullo riconosceva la necessità del vincolo al metodo democratico, ma lo collocava sul piano politico, individuando nel confronto parlamentare e nell’opinione pubblica la sede naturale del giudizio sull’operato delle forze politiche.
Così, sebbene la nostra Costituzione non contenga una disposizione esplicita che vieti la formazione di partiti contrari ai principi democratici, tale divieto può essere ricavato in via sistematica da altre norme della Carta. Diversamente si atteggia la Legge fondamentale tedesca, che all’art. 21, comma 2, prevede espressamente la possibilità di dichiarare incostituzionali i partiti che si pongano in contrasto con l’ordine democratico e liberale fondamentale (freiheitlich-demokratische Grundordnung).
INDIRIZZO POLITICO E METODO DEMOCRATICO
La forma di governo parlamentare italiana si definisce tipicamente monista, poiché il governo è politicamente responsabile esclusivamente nei confronti del Parlamento. Tuttavia, l’esperienza repubblicana dimostra l’esistenza di una concezione in parte dualistica della responsabilità politica.
Le frequenti crisi extraparlamentari, originate non da un voto di sfiducia ma da tensioni interne alle coalizioni, evidenziano come i ministri, essendo espressione dei partiti, risultino politicamente responsabili anche verso il proprio partito di appartenenza. Quest’ultimo, infatti, ha interesse a vigilare affinché il proprio rappresentante realizzi le linee programmatiche definite in sede politica.
Ne deriva che i partiti si configurano come i reali detentori dell’indirizzo politico, poiché, attraverso i gruppi parlamentari, possiedono la capacità di condizionare, modificare o addirittura far cadere le maggioranze.
In questa prospettiva, i partiti si presentano come veri e propri soggetti di diritto costituzionale, ai quali spetta il compito di mediare tra lo Stato e la comunità, svolgendo quella funzione di “cinghia di trasmissione” che valorizza il diritto di ciascun cittadino a concorrere, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale, come sancito dall’art. 49 della Costituzione.
LA SELEZIONE DELLE CLASSE DIRIGENTE
Dopo aver analizzato la funzione del partito e la sua evoluzione storica nel contesto italiano, è necessario soffermarsi sui metodi di selezione della classe dirigente. Secondo Gramsci, la funzione del partito non si esaurisce nella mera rappresentanza elettorale: esso agisce come un vero e proprio intellettuale collettivo, una scuola di formazione politica e morale. In questa prospettiva, il partito deve formare i propri quadri, educare i militanti e selezionare i dirigenti sulla base di capacità, competenza e senso di responsabilità, valorizzando coloro che dimostrano di saper interpretare i bisogni sociali e tradurli in progetti politici concreti.
La selezione, dunque, non dovrebbe avvenire secondo logiche di fedeltà personale o di appartenenza ristretta, ma attraverso meccanismi trasparenti, inclusivi e realmente democratici. Essa dovrebbe poggiare su un percorso di crescita, un cursus honorum che premi il merito, l’impegno e la dedizione, e che consenta di individuare i dirigenti più idonei a guidare la comunità politica.
In particolare, i congressi rappresentano il momento decisivo in cui tale processo dovrebbe esprimersi, consentendo la selezione dei “migliori” all’interno dei diversi organi dirigenti del partito. In questo modo si garantisce non solo un ricambio formale, ma anche un ricambio qualitativo, capace di far emergere e mettere al servizio della collettività le energie migliori.
Ciò non implica ignorare l’esistenza delle correnti, che inevitabilmente caratterizzano la vita interna di ogni partito. Significa piuttosto intenderle non come mere reti di legami personali, ma come espressione di differenti culture politiche e di diverse letture strategiche su come realizzare la visione comune posta alla base del partito. In questa accezione, le correnti possono arricchire il pluralismo interno e contribuire alla vitalità democratica dell’organizzazione.
IL PARTITO DEMOCRATICO COME ESEMPIO DI PARTITO LIQUIDO
Il Partito Democratico incarna oggi in modo esemplare la crisi del partito liquido, ossia un soggetto politico privo di radicamento sociale, identità culturale solida e regole interne realmente democratiche. Nato con l’ambizione di fondere culture diverse e di dar vita a una forza politica nuova, capace di parlare a un Paese complesso, si è progressivamente trasformato in un organismo informe, oscillante tra leadership effimere e alleanze di convenienza, incapace di elaborare un progetto riconoscibile.
Questo limite appare con particolare evidenza nella gestione di Elly Schlein, che pure si era presentata con il volto del rinnovamento e la promessa di restituire centralità alla base. Nei fatti, però, la sua segreteria si è rivelata debole e contraddittoria: le scelte politiche sono state spesso guidate dalla necessità di preservare equilibri interni, più che dall’intenzione di aprire spazi reali di confronto. Lo dimostra il caso del commissariamento del PD campano, annunciato come una battaglia contro i “cacicchi” locali ma conclusosi con un accordo con Vincenzo De Luca, che ha segnato la resa al sistema di potere territoriale che si voleva combattere.
Sul piano nazionale la linea non è stata diversa. Schlein ha preferito evitare il ricorso a congressi veri, rinunciando a presentare mozioni alternative e affidandosi a compromessi unitari che hanno congelato il dibattito interno. In questo modo ha impedito la nascita di un ricambio generazionale e qualitativo, riducendo la militanza a semplice manovalanza nelle campagne elettorali o nelle Feste de l’Unità, senza un reale ruolo nelle decisioni strategiche. Le correnti non sono state superate, ma semplicemente inglobate in un sistema di equilibri che ha rafforzato lo status quo.
Così il Partito Democratico non funziona come una comunità politica viva, ma come un contenitore adattivo, privo di coerenza e visione, che cambia forma in base alle circostanze. La promessa di rinnovamento si è trasformata in gestione conservativa, e il risultato è un partito sempre più liquido, capace di sopravvivere ma non di rappresentare.
VERSO UN PARTITO NUOVO, COME ALTERNATIVA AL SISTEMA CAPITALISTICO
Se il Partito Democratico è diventato l’esempio di un partito liquido, incapace di rappresentare e di selezionare in modo credibile la propria classe dirigente, e se l’attuale sistema politico appare svuotato di vere comunità politiche, allora la questione non è se serva un nuovo soggetto, ma quando e come costruirlo. Non si tratta di aggiungere un’altra sigla all’elenco dei micropartiti esistenti, ma di dar vita a una forza in grado di ricostruire il legame tra società e istituzioni, restituendo senso alla partecipazione e dignità alla politica.
Un partito nuovo deve nascere non dalla somma delle debolezze, ma dalla sintesi di una visione coerente. Deve saper parlare ai ceti popolari, agli esclusi, ai lavoratori precari e a chi oggi vive ai margini della cittadinanza, ma senza rinchiudersi in una logica minoritaria. Per riuscirci, deve recuperare il ruolo del partito come comunità politica: non un comitato elettorale permanente, non un brand affidato all’immagine del leader, ma un luogo di formazione, di confronto e di elaborazione collettiva. In questa comunità la militanza deve tornare a contare, non come residuo nostalgico del passato, ma come pratica concreta di democrazia, fatta di assemblee, congressi reali, decisioni discusse e condivise.
Fondamentale sarà la selezione della classe dirigente. Un nuovo partito non può permettersi di riprodurre le logiche dinastiche, i sistemi clientelari o i personalismi mediatici che hanno segnato le esperienze precedenti. La selezione deve avvenire lungo un cursus honorum che premi merito, capacità, responsabilità, impegno sul territorio e coerenza tra parole e azioni. Solo così sarà possibile valorizzare le energie migliori e garantire un ricambio non solo generazionale, ma anche qualitativo. In questo senso, il nuovo partito deve funzionare come un intellettuale collettivo, in grado di formare coscienza critica e di trasformarla in progetto politico.
Sul piano dei contenuti, tre sono i pilastri irrinunciabili. Il primo è la giustizia sociale, che significa lotta alle disuguaglianze, difesa dei diritti sociali e centralità del lavoro come strumento di emancipazione e dignità. Il secondo è la sostenibilità ambientale, non come slogan ecologista, ma come scelta strutturale di modello di sviluppo: politiche urbane inclusive, gestione dei beni comuni, transizione energetica equa. Il terzo è la pace internazionale, intesa non come formula retorica ma come progetto politico, capace di proporre un modello di cooperazione multilaterale e di difendere il principio, scolpito nell’art. 11 della Costituzione, del ripudio della guerra.
Accanto a questi pilastri, un nuovo partito deve riscoprire l’importanza dell’etica pubblica: trasparenza, responsabilità, incompatibilità chiare tra incarichi politici e interessi personali, rifiuto delle rendite di posizione. Non bastano programmi e slogan se la politica non dà esempio di credibilità e di sobrietà. Per questo il nuovo soggetto non deve nascere come una copia aggiornata dei modelli del passato, ma come radicalità riformista, capace di coniugare rigore etico e coraggio politico.
Un progetto di questo tipo non è utopia, ma necessità. L’alternativa è rassegnarsi a un sistema politico in cui i partiti sopravvivono senza più rappresentare, amministrano senza più trasformare, inseguono il consenso senza più dare voce a chi non ce l’ha. Un nuovo partito è dunque l’unica via per restituire alla politica la sua funzione originaria: mediare tra lo Stato e la società, dare forma ai conflitti sociali e costruire un futuro comune.
***
ARTICOLI PRECEDENTI