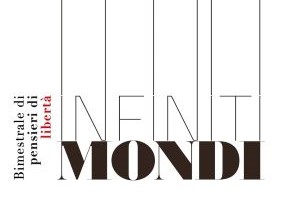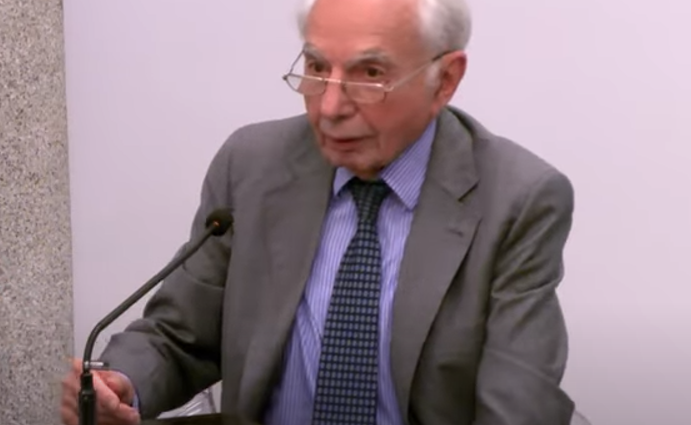Un po’ livoroso, come sa esserlo solo chi si ostina a rimandare qualsiasi tentativo di pacificazione col passato, ma anche leggermente inopportuno per tempi, modi e toni, Giuliano Amato ha pensato di onorare la memoria di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita per gettare più di un’ombra su quella di Enrico Berlinguer.
Un primo elemento di valutazione non può non essere storiografico, e riguarda l’utilizzo di quella che gli specialisti definiscono “storia controfattuale”: cosa sarebbe accaduto, cioè, se nel 1968, anziché Berlinguer il Pci avesse deciso di affiancare Napolitano a Luigi Longo come vicesegretario, tracciando la traiettoria che avrebbe portato il primo, 4 anni dopo, al vertice di Botteghe Oscure? Amato non ha dubbi: non la storia della sinistra, ma “la storia d’Italia (addirittura, ndr) sarebbe stata diversa”. Un esercizio apodittico, che rasenta – sia consentito – la chiacchiera da bar. Tanto per dire: quale sarebbe stata la storia del Psi (e, a questo punto, del Paese intero) se, in quel torrido luglio di 49 anni fa al Midas, anziché Bettino Craxi, alla segreteria del partito fosse asceso Antonio Giolitti, com’era nelle previsioni della vigilia?
Il secondo elemento di valutazione è, ovviamente, politico. E parte dalla riapertura di antiche ferite che si davano per suturate, ma che sanate evidentemente non sono. L’intervento dell’ex presidente del consiglio sembra provenire, infatti, da un’altra era geologica: dai tempi della cosiddetta “guerra civile a sinistra”, un conflitto durato meno di dieci anni (più o meno dal 1976 al 1984, anno della prematura scomparsa di Berlinguer) che, pur investito in pieno ma mai efficacemente derubricato dagli sconvolgimenti epocali abbattutisi sulla sinistra italiana dal 1989 in poi, ha lasciato tuttavia in giro tossine e scorie fastidiose, urticanti. Ne ha parlato, un paio di anni fa, in un bel saggio, Squarcio rosso. Berlinguer, Craxi e la sinistra in pezzi, il giornalista e storico Giampiero Calapà, che ha l’indiscusso merito di non ricostruire le vicende del passato con il famoso “senno del poi” (l’anacronismo di chi scrive di storia, che faceva inorridire Marc Bloch). Nel suo libro, Calapà, si guarda bene dal porsi la famosa domanda “cosa sarebbe accaduto se…”, limitandosi a ricostruire e analizzare le cause di quel conflitto. Giungendo alla conclusione – suppergiù – che, alle condizioni date, quella guerra non poteva essere evitata, tanto profonde erano le differenze affiorate tra i duellanti di quella vicenda, vale a dire Craxi e Berlinguer.
Le parole di Amato riattizzano le ceneri perché recuperano il principale argomento della polemica che veniva usato nel campo socialista, ma di converso anche nel campo comunista, contro i rispettivi antagonisti: e cioè se con altri protagonisti in campo quella divisione così netta e radicale tra i due partiti ex fratelli si sarebbe prodotta lo stesso o sarebbe stata evitata. Una semplificazione brutale che taglia con l’accetta storie complessissime, come quelle del Pci e del Psi nel secondo Novecento. Tanto per dire: la presenza, nella dialettica interna al Pci, della cosiddetta “ala migliorista” e, di converso, in quella del Psi delle sinistre demartiniana e lombardiana fanno strame dei luoghi comuni che negli anni successivi accompagneranno la rottura della trama unitaria tra i due maggiori partiti del movimento operaio. Caratterizzata sì da una contesa talvolta aspra per la leadership sulla sinistra italiana, ma sempre nell’ambito di una collaborazione, dialettica quanto si vuole ma intensa e ininterrotta: nel sindacato e nelle altre grandi organizzazioni di massa, nel movimento delle cooperative, grazie al quale erano stati possibili significativi “trapianti” di economia socialista in alcuni ambiti e settori sottratti al controllo del capitalismo privato, e nelle giunte “rosse”, che erano dilagate a macchia d’olio dopo la grande affermazione delle sinistre (soprattutto del Pci) alle amministrative del 1975.
Mai – nemmeno nei momenti di tensione più acuta, che non erano certo mancati – era stato messo in discussione il comune “ceppo”, sentimentale e emotivo prim’ancora che ideologico e politico, da cui discendevano i due partiti. È vero, quindi: la faglia che si aprì nella seconda metà degli anni Settanta fu così profonda da inghiottire tutte insieme queste dimensioni. Ma riproporla surrettiziamente oggi, come fa Amato (il suo non detto è la mancata “socialdemocratizzazione” del Pci per colpa di Berlinguer) non ha altro senso che quello di rinfocolare vecchi rancori superati dagli sviluppi successivi della vicenda politica italiana e internazionale. Un dato su tutti avrebbe dovuto indurre a maggiore cautela l’ex premier. Berlinguer muore cinque anni prima dell’autodissoluzione dell’Urss, quando la sinistra italiana – nonostante la guerra civile – sfiora nel suo complesso il 50% dei voti, in un assetto basato sul proporzionalismo elettorale. In quegli anni, il segretario del Pci è impegnato in una fitta interlocuzione con Olof Palme, Willy Brandt, Bruno Kreisky, in pratica l’”aristocrazia” della socialdemocrazia europea, sull’onda di un idem sentire in materia di equilibri geopolitici internazionali. Napolitano, che era quasi suo coetaneo (solo tre anni di differenza) gli sopravvive 40 anni, e sono 4 decenni nel corso dei quali la sinistra italiana cambia completamente pelle (eufemismo), forse (ma possiamo solo supporlo) nel senso auspicato da Amato. E solo una volta – a condizioni istituzionali radicalmente mutate, perché intanto a quella proporzionale s’è sostituita la civiltà maggioritaria – arriva intorno al 40%.
Il terzo – e conclusivo – elemento di valutazione è, per così dire, privato. Potremmo ovviamente sbagliarci, ma molto difficilmente il commemorato avrebbe apprezzato le parole di Amato. Al di là delle divergenze (sfociate nel clamoroso intervento su l’Unità del futuro Capo dello Stato a proposito di questione morale), tra Enrico Berlinguer e Giorgio Napolitano ci fu un rapporto di amicizia e di collaborazione leale e sincera: basta leggere le bellissime pagine che Napolitano dedica al segretario nella sua autobiografia, Dal Pci al socialismo europeo. È lui, il comunista di Monte di Dio, a rappresentare la segreteria del Pci in giro per il mondo. America compresa. Rappresentarlo, quasi sessant’anni dopo quella investitura che li vide contrapposti, come un feroce antagonista di Berlinguer è una di quelle forzature a cui la storia ci sta purtroppo abituando, nel tentativo tutto autolesionistico di negare sé stessa.
PS Nel luglio del 1976, al Midas, al Comitato Centrale del Psi uscito sconfitto dalle elezioni politiche, in pole position per la sostituzione di Francesco De Martino alla segreteria c’era Antonio Giolitti. Tra i suoi sostenitori, figurava anche Giuliano Amato: nato politicamente nel Psiup, quattro anni prima, nel 1972, allo scioglimento di quel partito era entrato nel Psi. Archiviata la “battaglia” del Midas, nel quindicennio successivo Amato sarebbe stato uno degli esponenti più autorevoli della maggioranza craxiana che guidò il partito dal 1976 fino alla sua dissoluzione, nel 1994.
Massimiliano Amato