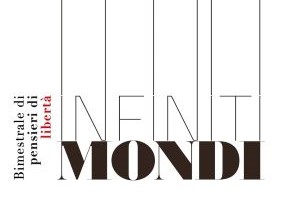Le origini e le cadute dell’internazionalismo
Nella storia del socialismo europeo ci sono fasi di pronunciato internazionalismo e fasi invece di ripiegamento atlantista, nonché, ė il caso del primo conflitto mondiale, casi persino di soggezione al nazionalismo guerrafondaio. Nella fase attuale abbiamo qualcosa di parzialmente inedito: una identificazione pressoché assoluta del socialismo europeo con l’Occidente, che confonde la fedeltà ai principi democratici (ovviamente imprescindibili per ogni socialista) con la diffidenza, se non il rifiuto, verso un nuovo multipolarismo che avanza, e che può soltanto essere riconosciuto e negoziato (finché si è in tempo).
Nel caso del primo conflitto mondiale, a paragone, se i partiti socialisti di Francia e Germania cedettero alla solidarietà verso lo sforzo bellico nazionale, furono nondimeno molti i partiti e movimenti socialisti a tenersene fuori. I socialisti nordici mantennero fede al proprio neutralismo, un seme che sarebbe rimasto fruttuoso specie durante la guerra fredda, in cui anche i nordici membri della NATO avrebbero tenuto posizioni critiche verso le politiche di potenza del proprio campo, avvicinandosi molto alle necessità del Sud del mondo post coloniale. Da ricordare poi che anche, forse soprattutto, il socialismo italiano si rifiutò fin da prima del 1915 al gioco di potenza nazionale, in nome di una fedeltà all’interesse delle masse lavoratrici a non farsi massacrare, e poi, più costruttivamente, volendo destinare risorse allo stato sociale piuttosto che agli eserciti (fatta salva ovviamente la difesa della repubblica democratica). Il socialismo italiano è infatti al meglio rappresentato dalla lunga continuità che va da Matteotti alla neo-atlantismo della Prima Repubblica, capace quest’ultimo di tenere insieme oggettiva alleanza occidentale, culto dei valori democratici (mai posti in discussione) e autonomia/distinzione dall’imperialismo di alcuni paesi alleati. Ciò aveva radici nell’indefettibile opposizione al fascismo espansionista (e razzista) e al colonialismo ritardatario dei Savoia, di cui la Repubblica Democratica era, in politica estera e in tutto il resto, opposto diametrale. Matteotti nel 1915 scrisse su questa stessa rivista: “Un milione di proletari organizzati nell’Italia settentrionale sono sufficienti a far riflettere qualsiasi governo sull’opportunità di aprire una guerra; poiché non soltanto noi dovremmo preoccuparci di aggiungere anche la guerra civile; e non sappiamo fino a dove si possa temere uno spargimento di sangue, se altrimenti la guerra moderna falcerebbe, nel nostro stesso campo, centinaia di migliaia di vite”.[1] Quello dei socialisti era un patriottismo perfino alieno a celebrare vittorie, tanto che Matteotti, nel 1923, dissente animosamente da Turati che aveva partecipato alla celebrazione del “Milite ignoto”, riprodotta sul quotidiano del loro partito (“La Giustizia”) come “celebrazione della Vittoria”, scelta per Matteotti inaccettabile. Secondo Matteotti, al massimo, “si comprende l’esaltazione di una Difesa vittoriosa, ma non di una Vittoria che per un altro proletariato si risolve in una sconfitta e in una oppressione”. Per il futuro l’unico patriottismo si sarebbe dovuto ispirare alla linea “Patria libera e mondo senza guerre. Mai più oltre”.[2] È esattamente questo rifiuto della “Vittoria” (sempre apparente e caduca, peraltro) a doverci far valutare criticamente i primi decenni del post-guerra fredda. Ed è sempre quel rifiuto a spingerci verso un nuovo internazionalismo ed un multipolarismo paritario.
L’internazionalismo nella guerra fredda
Il nostro Paese, e il PSI in esso assieme alle socialdemocrazia nordiche, mirò nel secondo dopoguerra a proporre una presenza occidentale nel Sud del mondo alternativa all’imperialismo e al post-colonialismo. Tanto che possiamo affermare esserci molte continuità fra Matteotti e Sigonella. Una continuità non contraddetta del tutto nemmeno dalla questione degli euromissili, in cui Craxi si schierò in effetti vicino a Helmut Schmidt: una scelta certo utilizzata anche contro il PCI nel duello a sinistra, ma mai in ottica ideologicamente occidentalista, e sempre mantenendo in ogni modo possibile aperta la trattativa con l’URSS.
Ciò che più importa, poi, è che la linea di apertura e amicizia verso il sud globale (spesso nella letteratura storica detta “likemindedness”) si era imposta, nell’Internazionale Socialista (IS), allorché si era indebolita invece la sua prima fase meramente atlantista. Durata per tutti gli anni Cinquanta ed oltre, quella fase da un lato concepiva un socialismo democratico del tutto eurocentrico, ed anzi euro-occidentale, e dall’altro (nel caso almeno francese) cercava di mantenere i domini coloniali pensando di assicurare per esempio agli algerini diritti civili e sociali paritari con la Francia metropolitana. Con la decolonizzazione e il protagonismo del Sud globale (Movimento dei non allineati, lotte di liberazione e riscatto, Nuovo Ordine Economico Internazionale e maggiore impatto alle Nazioni Unite)[3] la fase atlantista della IS termina, e s’impongono nuove figure. Per l’Italia entra nella IS il PSI, che vive la NATO in modo più distaccato e meno ideologico. Soprattutto si impongono figure come Palme, Kreisky e Brandt (nonché i meno conosciuti olandesi Den Uyl e Pronk, e tanti altri) molto decisi ad imprimere una svolta. Si tratta di esperienze storiche diverse ma convergenti: neutrali che avevano da secoli sperimentato l’impossibilità di essere potenze (la Svezia di Palme); neutrali che avevano più recentemente riconosciuto questa impossibilità (l’Austria di Kreisky) e che dopo l’Anschluss si erano soprattutto vaccinati per sempre da ogni “rinascita germanica”. C’era anche la Germania di Brandt, che portando al potere il suo primo cancelliere pienamente socialista ed antifascista, voleva segnalare non solo entrando nella NATO e nella CEE, ma anche con un nuovo atteggiamento di dialogo (la Ostpolitik) e di forte internazionalismo (l’apertura della IS al sud del mondo), che ogni sua ambizione di grande potenza militare era il passato.
C’erano infine paesi (Norvegia e Danimarca) che per la loro posizione geostrategica erano stati invasi dal nazismo e poi liberati dagli Alleati, e non potevano dunque fare a meno di entrare nella NATO. Anche essi continuavano tuttavia con la Svezia a concepirsi come “piccole economie” del welfare state avanzato, sempre quindi interessate ad una distensione e ad un ordine internazionale che non si accontentasse di essere “regolato”, ma proprio inibisse qualunque logica di potenza. Solo così i “piccoli paesi” come quelli nordici “socialdemocratici”, o i paesi “mai più potenze” come la Germania di Brandt (e l’Italia anti-fascista) potevano praticare indisturbate e coerenti le proprie nuove identità. E, sembra paradossale ma non lo è, solo rinunciando ad una strategia di potenza, potevano al contempo avere reale e progressiva sicurezza, costruendo così un nuovo interesse nazionale.
Palme utilizzava per questo la retorica dei “piccoli paesi”, intendendola come condizione comune, diceva, alla sviluppata Svezia e al Sud del mondo, ma anche agli ex imperialisti Paesi Bassi rispetto alla loro antiche colonie.[4] In qualunque sistema di alleanze si trovassero, tutti questi paesi avevano interesse comune a non farsi imporre una logica di potenza (fosse anche nell’ordine regolato dell’ONU) che ne avrebbe presto compromesso sicurezza e sviluppo economico. Per questo, l’Onu doveva crescentemente essere governato da una logica di “un paese un voto”.
Le inadempienze dei partiti PSE
Se l’attuale socialismo europeo è ripiombato in una fase non internazionalista, ed invece unilaterale e occidentalista (sebbene costretta da Trump a non essere più atlantista, piuttosto “europeista-occidentalista”) è perché la fine della guerra fredda non è stata interpretata secondo le premesse migliori della propria cultura politica. Sarebbe stata l’epoca di lavorare per una guida occidentale (poiché forse inevitabile nel 1991) che intuisse però l’impossibilità del proprio dominio (cioè l’insicurezza globale crescente insita nelle sue conseguenze), e invece la fruttuosità di condurre le relazioni internazionali verso una graduale inclusione multipolare nel governo del mondo. Anche volendosi mantenere nel nostro punto di vista di Nord Globale, nulla avrebbe legittimato il ruolo di guida “nord Atlantico” quanto questo atteggiamento. L’approccio occidentale è stato invece ben altro: si è imposto il mondo della globalizzazione neoliberale, mentre la pretesa superiorità dei valori neoliberali occidentali, con i suoi doppi standard e le sue frodi (esattamente: frodi), ha indebolito purtroppo l’immagine e la sostanza delle nostre democrazie. Questo ha poi innescato le retoriche nazionaliste, occidentaliste e anti occidentaliste del presente.
Alla base del regresso ideologico, politico ed economico dell’attuale socialismo europeo (rappresentato dal PSE in modo avvilentemente plastico) è stato il voler accettare la sfida neoliberale senza davvero competere con essa e con il modello di “Occidente” che veicolava. Ovviamente, questo non significa totale uniformazione, sia chiaro. Ma mancanza di alternativa sì. Per esempio, fra l’idea di Ostpolitik di Brandt (una distensione paritaria in cui i sistemi diversi convivevano nella loro diversità e così si stabilizzavano vicendevolmente) e quella di Merkel (la convinzione che fornire energia alla macchina di esportazione tedesca avrebbe ripagato la Russia da ogni cosa e che l’avanzata della NATO non avrebbe trovato un imprenditore politico disposto ad investire in nazionalismo) passa un abisso.
Ma le differenze e le distinzioni fra il socialismo democratico e i suoi avversari non sono state utilizzate, forse nemmeno tematizzate. La mancata alternativa internazionalista da parte del socialismo democratico ha permesso che gli imprenditori del nazionalismo potessero sfruttare uno spazio che i leader e i cantori del globalismo neoliberale/occidentalista non hanno visto arrivare se non come residuo reattivo al “giusto inevitabile progresso” veicolato dall’Occidente. Insomma, fuori dal perimetro dell’avanzata occidentale si vedeva poco più che “fondamentalisti” o “stati canaglia” da schiacciare. Tutt’altro che residuale, questo spazio è stato generato al contrario dal difetto iniziale della globalizzazione cui si accennava sopra: non è avvenuta l’omogeneizzazione occidentale e neoliberale attesa, al contrario nuovi poteri e potenze hanno mantenuto una propria soggettività (nel competere economicamente nonché nel proporsi politicamente). La Cina, esempio principe, non è divenuta un’immensa potenza economica perché si è occidentalizzata, ma precisamente perché ha utilizzato dei propri “depositi” di pensiero (anche economico).[5] Nonché uno Stato efficiente ed alieno da vincoli post-coloniali. Questo va riconosciuto non per diventare cinesi, come certi grotteschi vecchi maoisti di un tempo poi divenuti iper-cattolici, bensì per agire da socialisti democratici con intelligenza. Cioè con rispetto per la nostra cultura politica, sicuri di essa nel confronto paritario con quella altrui.
Ciò comporta constatare che la soggettività della Cina e dei Brics non è stata “residua”, bensì è divenuta “esemplare” (in senso etimologico) e perciò addirittura crescente. Essa dunque non è omologabile all’espansione dei valori occidentali (buoni come meno buoni) né è tantomeno possibile schiacciarla. In sostanza: non essendo la globalizzazione neoliberale nata per interpellare paritariamente le nuove soggettività del sud del mondo, queste hanno purtroppo cominciato a ragionare in termini di alterità e antagonismo verso il Nord, piuttosto che di integrazione come trionfalisticamente si attendeva qualcuno, dopo avere pensato di annullare ogni altra soggettività schiacciando “dimostrativamente” Saddam Hussein.
Inevitabilmente, questo contesto si è anche purtroppo tradotto in conflitto. E ancora: non ci interessa affatto giustificare nulla, e certo non giustifichiamo né l’invasione dell’Ucraina, né Hamas, né le frodi internazionali perpetrate da Blair e Bush, né gli immani massacri che quelle frodi hanno permesso. Ci interessa solo capire e riproporre una soluzione internazionalista e socialista a tutto questo disordine.
Le ragioni della eclissi socialdemocratica
E ora torniamo alle socialdemocrazia del PSE. Quali sono state dunque le particolarità della socialdemocrazia nel PSE rispetto al globalismo neoliberale? Direi questo: non inesistenti ma insufficienti. Negli anni 1990 si era posto nettamente sotto attacco il modo socialdemocratico, soprattutto nordico, di stare nella globalizzazione. La cultura ordoliberale della UE attaccava i fattori economici della parità di classe (in sostanza l’equilibrio fra esportazione e domanda interna). Le ideologie neoliberali anglosassoni andavano forse anche oltre: i modelli socialdemocratici nordici erano ritenuti frutto dell’antropologia (per esempio un’assurda propensione nordica a pagare alte tasse, che però nel mercato globale avrebbe condotto le loro economie alla sclerosi) e non della politica economica (l’alta occupazione ad alti salari che, assieme alla netta preferibilità del welfare pubblico, lascia meno spazio ad un malcontento fiscale, che però ovviamente come altrove non era mai morto). I paesi Nordici, e quelli in genere ad elevato impatto storico socialdemocratico, avevano però dalla loro la tendenza a competere con più innovazione proprio perché non avevano lasciato al capitalismo molto spazio alla competizione da sfruttamento. Questo è sempre un dato strutturale, economico ed ideologico fondamentale, che aveva permesso ai partiti del PSE di contrapporsi alla globalizzazione neoliberale grazie all’idea di nuova “società della conoscenza”. Cioè una società che avrebbe permesso di distribuire chance ed opportunità mediante “l’inclusione capacitante”, ovvero nella capacità di risultare interessanti e relativamente ben pagati in un mercato del lavoro globalizzato. Le vittorie del PSE negli ultimi anni 1990 si devono a questa controproposta e alla sua efficacia retorica. Tuttavia, il regresso elettorale massiccio poi seguito si deve ai limiti forti di quell’approccio, ovvero alla sua incapacità di riprodurre i fattori politici, sociali, di classe che avevano condotto dagli anni 1930-40 proprio ad opporsi efficacemente allo sfruttamento capitalista, e su ciò ad unire classi operaie e medie. Quella nuova incapacità di combattere lo sfruttamento dipendeva dal fatto che i parametri di Maastricht e le logiche di bilancio neoliberali rendono impossibile distribuire in domanda interna (eminentemente welfare, diritti, salari e relativa parità democratica di classe) i successi economico-commerciali delle singole economie europee, anche di quelle nordiche. E non esiste alcuna possibilità di competizione senza sfruttamento se, come deriva dai dettami ordoliberali di Maastricht, questa redistribuzione non avviene in modo sistematico. Così, sempre di più sono e saranno gli elettori che percepiranno l’idea di “giuste opportunità” nella “società della conoscenza” come pura retorica. Ecco allora che la soggettività del socialismo democratico si indebolisce elettoralmente, socialmente e quindi ideologicamente. Il modo socialdemocratico di stare nella UE e nell’interdipendenza globale (o globalizzazione neoliberale) dipende quindi sempre più dall’essere competitivi in modo “export-led”, mentre come abbiamo visto il vero socialismo democratico può solo essere duplice: il suo modo di essere competitivo presuppone anche paritari e potenti fattori di domanda interna. Con l’asfitticità di questi fattori, avviene quindi l’assimilazione fra partiti PSE (specie nordici) e ragioni espansive (sviluppo finanziarizzato, ricerca di sbocchi all’export senza pari contributo di domande nazionali che li alimentino) tipiche della globalizzazione neoliberale.
Altre ragioni di questa assimilazione sono indotte invece dall’assalto ideologico delle destre interne ai vari paesi, un assalto che appunto trova i socialisti europei molto più vulnerabili ideologicamente, socialmente ed elettoralmente. Ad esempio, i governi neoliberali nordici dagli anni 1990 mettono sempre più in discussione la cultura della neutralità, oppure il modo critico, perfino quasi “terzomondista”, delle socialdemocrazie di stare nella NATO e nell’ONU. Palme è sempre stato (ingiustamente, strumentalmente) accusato di indifferenza o abbietta equanimità fra democrazia e totalitarismo, così che in molti modi la sua “neutralità attiva” è stata tacciata di ipocrisia. Nel caso danese, l’adesione alla “war on terror”, ovvero alla disastrosa destabilizzazione del Medio Oriente e al massacro del popolo iracheno perpetrato grazie alla produzione di prove false, è stata motivata dall’allora governo di destra come un riscatto dall’ignominia storica di non avere combattuto davvero contro gli invasori tedeschi. In realtà le principali forze politiche danesi (anche norvegesi) si erano divise nel 1940-1943, anche al loro interno, sull’atteggiamento da adottare. Chi operava nelle istituzioni cercò perlopiù un aggiustamento con l’invasore nazista che limitasse il suo controllo sulla società danese. Ma altri (comunisti, socialdemocratici e conservatori, spesso poi assurti a ruoli di grande livello) operarono nella Resistenza. Ad ogni modo, dopo il 2000 la destra liberal-conservatrice del premier Anders Fogh Rasmussen (poi a capo della NATO) propagandò un’adesione totale alle guerre Neocon per sdebitarsi con gli anglosassoni, da cui i danesi si erano secondo lui indegnamente e passivamente lasciati liberare nel 1945.
Ciò che possiamo constatare è che, indeboliti i propri strumenti economico-politici di distinzione e consenso sociale, le socialdemocrazie, e quelle nordiche in particolare, sono state sempre più vulnerabili alla offensiva occidentalista della destra. Così, nel post-guerra fredda, non hanno più lavorato alla distensione e alla prevenzione delle politiche di potenza, occidentali ed altrui. Mancando tutto questo, non sono più riuscite a rimanere estranee alla logica dei nazionalismi contrapposti (e a differenza del passato, quindi, non si sono più offerte quali operatori credibili di distensione), e sono quindi rimaste coinvolte nel circolo vizioso di paure e di ansie che le ha proiettate addirittura in prima linea. Specie l’abbandono della neutralità da parte di Svezia e Finlandia è stato infatti preceduto da un’incrementale integrazione militare con forze NATO che avevano reso la stessa neutralità sempre meno pura. Come si è visto, e come abbiamo scritto in varie occasioni, il circolo vizioso della logica di potenza, quando non scongiurato dai socialdemocratici e dai nordici, poi finisce per colpirli in pieno: sono infatti giunte puntualmente le pretese USA sulla Groenlandia.
La ricetta di Myrdal per L’internazionalismo democratico
In passato, una delle dottrine più tipiche dell’internazionalismo socialista era quella per cui Gunnar Myrdal, ministro socialdemocratico svedese e Nobel 1974 per l’economia, raccomandava un “nazionalismo controllato e razionale” che consentisse “dentro e fra le nazioni” di convogliare le forze dei ceti e dei paesi subordinati che si opponevano alla disuguaglianza e alla povertà.[6]
Si trattava come ben si comprende di riconoscere ai singoli paesi, e specie alle forme di solidarietà interne al Sud globale (intorno al Nuovo Ordine Economico Internazionale), di costruire le modalità e i tempi della propria interdipendenza, concordati con istituzioni internazionali capaci di un approccio istituzionalista e strutturalista, ovvero non solo di applicare ristrutturazioni di bilancio derivate dalla modellistica neoliberale. I suggerimenti di Myrdal erano un esempio di vero inter-nazionalismo, cioè il contrario esatto di Istituzioni Finanziarie Internazionali dedite a piallare ogni soggettività ed esigenza sociale in modo sovra-nazionale, ovvero tecnocratico. In ultima analisi, internazionalismo significa ieri come oggi creare il presupposto per dissociare il concetto di democrazia e di interdipendenza economica dall’espansione neoliberale pura e semplice, economico-finanziaria e anche militare. E comporta realizzare quindi i presupposti istituzionali, sociali ed economici di una reale democrazia, di un reale pluralismo degli interessi interdipendenti (interessi di classe, nazionali, politici). Al di fuori dell’Occidente come ben dentro l’Occidente.
Paolo Borioni
[1] G. Matteotti, Contro la guerra: dal punto di vista del nostro partito, “Critica Sociale”, 1915, n.3.
[2] G. Matteotti, Epistolario 1904-1924, pp. 189-190.
[3] Gilman, N. (2015). The New International Economic Order: A Reintroduction. Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 6(1), 1-16. https://dx.doi.org/10.1353/hum.2015.0008.
[4] Ann-Marie Ekengren (2011) How Ideas Influence Decision-Making: Olof Palme and Swedish foreign policy, 1965–1975, Scandinavian Journal of History, 36:2, 117-134, DOI: 10.1080/03468755.2011.561189
[5] I. Weber, How China Escaped Shock Therapy. The market reform debate, Routledge, 2021.
[6] B. Stråth, The Brandt commission and the multinationals, Routledge, 2023, p. 30-32.


***
Storia della rivista
Dalla fondazione ai Moti di Milano
La rivista Critica Sociale venne ufficialmente fondata a Milano il 15 gennaio 1891 da Filippo Turati. Tra il 1891 ed il 1898, la rivista fu testimone della presenza politica e dell’autonomia del socialismo italiano e nelle sue pagine diventò l’interprete del periodo dell’intransigenza del partito che si stava fondando.
Il 1º gennaio 1893 Critica Sociale, che aveva pienamente accettato il programma del Partito dei Lavoratori Italiani approvato nell’agosto del 1892 al Congresso di Genova, cambiò il sottotitolo della testata Rivista di studi sociali, politici e letterari in Rivista quindicinale del socialismo scientifico ed iniziò ad affrontare tutti i gravi problemi pubblici degli anni Novanta (scandali bancari, repressione dei fasci siciliani, guerra di Abissinia, moti popolari per il pane) con articoli di forte denuncia.
In occasione dei Moti di Milano, il 1º maggio 1898 la rivista venne sequestrata e quindi interrotta a causa della condanna del suo direttore. Terminò così la prima fase della rivista, quella senza dubbio più animata e ricca di prospettive. Le uscite ripresero dopo più di un anno, il 1º luglio 1899.
Dal 1901 al 1921
La nuova fase per la Critica sociale si aprì nel 1901, in corrispondenza del periodo giolittiano. In questa fase la rivista diventò l’espressione della tendenza riformista all’interno del partito socialista. Vi trovarono ospitalità autori come Luigi Einaudi, Gabriele Rosa, Corso Bovio, Giovanni Merloni, Giovanni Montemartini, Claudio Treves, Leonida Bissolati, Carlo Rosselli, Alessandro Levi, Giacomo Matteotti e molti altri artefici del pensiero socialista e dell’azione riformista che diede unità sociale alla nuova unità politica della giovane nazione italiana.
Critica Sociale adottò, nel discutere di letteratura, una metodologia critica positivista e marxista e, convinta dell’efficacia del libro, dell’istruzione e delle biblioteche, offrì ai lettori, indifferentemente, i versi sociologici di Pietro Gori accanto alle poesie di Ada Negri e alle pagine di narrativa di Italo Svevo.
Quando l’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale venne deciso nel maggio 1915 Critica sociale non smise il suo neutralismo né le proprie ragioni riformiste e allo scoppio della rivoluzione bolscevica nell’ottobre del 1917, pur non negando la legittimità del metodo rivoluzionario dei bolscevichi, contestò la possibilità della sua applicazione in Italia.
Dal 1922 alla soppressione
Dopo la marcia su Roma (28 ottobre 1922) e la presa del potere dei fascisti, Critica Sociale venne sottoposta a censure e sequestri e con lealtà, ma priva di strategie, difese con coraggio l’ordine democratico travolto dal regime.
Gli ultimi articoli militanti uscirono all’indomani dell’assassinio di Giacomo Matteotti (10 giugno 1924).
Al termine dell’anno 1925 Critica Sociale si rifugiò sul terreno culturale-ideologico ma viene comunque soppressa con la legge fascista che vietava la stampa d’opposizione.
L’ultimo fascicolo, il n. 18-19, riporta la data 16 settembre – 15 ottobre 1926.
Il secondo dopoguerra
Critica Sociale riprese le pubblicazioni nel 1945 con l’autorizzazione del comando alleato in Italia firmato l’11 agosto.
Non era una rivista di partito, anche se al primo congresso del PSI dopo la Liberazione (aprile del 1946 a Firenze) Critica Sociale presentò una mozione contro la fusione tra comunisti e socialisti.
Da allora la rivista fece sempre riferimento a Giuseppe Faravelli e, poi, a Beonio Brocchieri della sinistra del PSDI di Saragat, scontando un certo isolamento politico che porterà alla crisi della casa editrice durante gli anni ’70.
Fu Bettino Craxi, appena eletto segretario del PSI nel 1976, a voler raccogliere le azioni della casa editrice di Critica Sociale per impedirne la scomparsa. Da allora la rivista sostenne sempre la linea cosiddetta “autonomista” del nuovo leader socialista, impegnandosi in modo particolare sul terreno della solidarietà ai gruppi del dissenso anti-sovietico nei paesi dell’Est europeo.
La direzione di Ugoberto Alfassio Grimaldi (1974-81) dette alla rivista un notevole rilancio, caratterizzandola anche con una maggiore apertura verso argomenti culturali. Una nuova interruzione delle pubblicazioni si registrò nel biennio 1992-’94, in seguito allo scioglimento del PSI.
Dopo lo scioglimento del PSI
Critica Sociale riprese le pubblicazioni in modo difficoltoso dopo due anni di interruzione nel 1994, unica testata giornalistica impegnata a contestare apertamente il clima creatosi attorno all’inchiesta nota come “Mani Pulite”.
Denunciò la limitazione della rappresentanza politica attraverso l’introduzione del maggioritario sostenendo la superiorità del sistema proporzionale da sempre sostenuto fin dagli albori della rivista.
Dal 2000 le pubblicazioni tornarono ad essere regolarmente mensili e dal 2005 la rivista ha adottato come nuovo sottotitolo quello di “Colloqui italo-britannici” per sottolineare il sostegno all’esperienza del New Labour di Tony Blair e le antiche e comuni radici nel socialismo fabiano di fine Ottocento, un socialismo non marxista di stampo liberal-democratico.
Nel 2011, in occasione dell’anniversario dei 120 anni dalla sua fondazione (15 gennaio 1891 – 15 gennaio 2011), Critica Sociale ottenne il riconoscimento dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica da parte di Giorgio Napolitano. L’anniversario fu celebrato nel segno della comune radice con il 150 anniversario dell’Unità d’Italia. Sotto questo aspetto, Critica Sociale è stata riconosciuta come una fonte preziosa di documentazione del processo di costruzione della nuova società nazionale post-unitaria. In particolare la rivista, con la sua attenzione al movimento socialista e al PSI, ha patrocinato l’ingresso del movimento dei lavoratori nel nuovo Stato unitario.
***
ARTICOLO PRECEDENTE