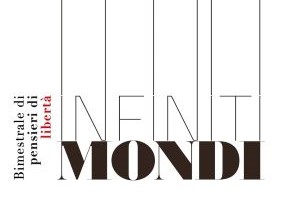Tema: dalla mia finestra vedo.
Svolgimento: Io vivo nei Campi Flegrei, a Monte di Procida, e dalla mia finestra vedo il mare (tanto), un Vesuvio che col Monte Somma forma la radice quadrata del fuoco, e, poi, Pozzuoli e, poi, Sorrento e Capri, e poi, Procida, e, poi, Ischia, che quando ha uno sbuffo sul Monte Epomeo segnala cattivo tempo. Quando c’è la fatamorgana vedo anche Ventotene. Io quando apro la mia finestra e mi guardo intorno, penso sempre a Conrad: “Come faccio a spiegare a mia moglie che quando sto affacciato alla finestra in realtà sto lavorando?”.
Poi punto il radar verso il basso, nella strada, e il vento arrolla negli angoli voci saracene, greche, latine, francesi, spagnole, pugliesi. Le ragazze, le immagino sempre in costume, quelli inventariati da Gea nel libro di cui parliamo e, non so perché – o forse lo so – con spighe di grano nei capelli.
Io dalla mia finestra vedo che la gente è preoccupata per il bradisismo ma io amo questi posti e da qui non mi muovono neanche i carabinieri.
Nel mio paese tra i quartieri di Casevecchie, La Piazza e Cappella si parlano tre dialetti diversi; ci aggiungo il bacolese, il baiano, il puteolano, il quartaiolo, la lingua di quella “metropoli dialettale “ che è Napoli ed ecco che mi sento in un’eco di etimologie e di archeofonìe ma poi mi viene l’ansia perché so che, fra pochi anni, con parlanti giovani ed addestrati con l’intelligenza artificiale, questo patrimonio non avrà eredi e sarà visto come un cascame. Non conosco il procidano o, meglio, lo conosco tramite il montese di Casevecchie e vorrei ascoltare una conferenza o un racconto in procidano fatto da vecchi e bambini, osservandone la gestualità e i timbri, un po’ come fece Roberto De Simone che raccontò una fiaba agli scolari dei Quartieri annotandone i gesti arcaici. Giro questa richiesta a Gea Palumbo.
Questo libro mi ha messo in moto, mi ha, appunto, motivato, h fatto il dovere di un libro, a dare un mio contributo in termini di informazioni: da un lato mie piccole note personali, dall’altro a vivere (meglio: ri-vivere) i “Campi Flegrei” come segno evocativo.
Mi hanno detto che i pescatori di Molfetta si spinsero coi loro gozzi fino a Napoli per aprire nuovi mercati ittici e si stabilirono a Procida, inaugurando il dialetto “collicellese”. Alcuni montesi hanno ancora parenti a Molfetta. I cognomi “Pugliese” e “De Candia” sono indicatori di questa piccola migrazione. A Monte di Procida una targa recita :“Via Inferno, luogo virgiliano”. Si tratta di un sito che non ha nulla a che vedere con Virgilio ed era chiamato “Abbasci’ ’o nfierno” in quanto c’era un cimitero ed era facile vedere nelle notti d’estate i fuochi fatui. L’episodio è indicatore di come può nascere un mito. Molti anni fa all’Archivio di Stato consultai la straordinaria opera del Giustiniani, “Regesto del Regno delle due Sicilie”, e mi soffermai sui due “Miseno”: il Capo e Monte di Procida, alias Monte Cumano. Leggendo il libro di Gea, mi sono ricordato che Enea fece costruire a Miseno nuove navi tagliando tronchi. Virgilio dice “ruit silva”. Si trattava, dunque, del rotolare di un bosco su una montagna e questa non può essere che Monte di Procida-Miseno, dotato di foreste, essendo da sempre il Capo molto brullo.
Ho voluto girovagare e ho appreso della Tabula Libitinaria, datata I sec. A.C., custodita nel museo di Baia; in essa vengono sancite le regole, l’apparato e gli ingaggi per il supplizio della Croce. Ho poi voluto intercettare il graffito della Crocifissione di Alcimilla (vicino l’Anfiteatro Flavio) che, scoperto da Maiuri e documentato da Camodeca, informa sia che le donne erano oggetto di tale supplizio sia che a Pozzuoli era presente una comunità cristiana. Del graffito con la croce di Alcimilla ne era a conoscenza un vecchio puteolano che sbarcava il lunario facendo la guida abusiva e, per dare importanza alla sua città, diceva, riferendosi al graffito: “Qui a Pozzuoli abbiamo un crocefisso del V secolo avanti Cristo”. L’aneddoto mi fu riferito da Angelo D’Ambrosio.
Dalla mia finestra vedo che i Campi Flegrei sono un museo a cielo aperto
e vedo che quello che vedo è trasportato da vele greche. I greci qui dovevano sentirsi a casa in quanto il paesaggio sia insulare che di terra è come quello greco. Ricordo che i trenta tiranni girarono le erme del Pireo verso la terra come a dire:”Basta col mare degli enti, il multiverso della democrazia. Torniamo alla terraferma dell’essere.” Immagino i personaggi del libro, ciascuno con l’abito della sua epoca, come statue sulla riva e col volto verso il mare. Uno, con la barba, guarda verso la mia finestra.
Gea , ri-cominciando dai nomi, ci fornisce una completa ri-sistemazione dei materiali flegrei anche in ordine alle innumerevoli fonti storiche. Le note sono 939, la bibliografia conta 21 pagine ed è preziosa ed utile per i ricercatori e i lettori che possono, se motivati, decidere per criteri temporali omogenei rispondendo alle domande:”Come era visto questo territorio nell’antichità’? e nel ‘600 o nell’800? Come era percepita la storia geologica, p.es., dopo il terremoto del 1538?”. In tal senso, la geologia è strettamente contagiata dal mito: un’apocalisse quasi permanente, perifrastica, un’arrassusia. Il corredo iconografico selezionato dalla Palumbo costituisce un viaggio nel viaggio. Un’incisione di Simone Porzio (1538) dal carattere biblico (il serpente originario, scale, dèmoni e dannati) l’ho messa all’inizio e alla fine di un altro mio percorso, simbolico, di lettura. Questa incisione è un po’ una sintesi della densità semantica del territorio: i titani, il ramo d’oro, la discesa agli inferi, l’incontro con i morti, le profezie sibilline, Caronte e la palus Acherusia. L’esplosione documentata da Antonio Delli Falconi è molto moderna, quasi uscita da un delirio di Max Ernst o dal “Libro Rosso” di Jung. Il ri-cominciare implica il ri-tornare, un “di nuovo” sui luoghi con lo spirito di Di Iorio (“andate e leggete”) arricchendo il proprio patrimonio di conoscenze.
L’incisione a pag. 254 rappresenta la porta d’oro e di corno da attraversare prima di scendere agli inferi. Ho avuto una sorpresa e un’illuminazione. Avevo sempre immaginato le due porte come adiacenti e da oltrepassare alternativamente: o questa, la porta d’oro, quella dei sogni, o l’altra, quella di corno, la realtà. Nell’incisione le due porte sono una dietro l’ altra il che significa che l’iniziato avrebbe dovuto attraversarle entrambe: dalla realtà al sogno e , ritornando sulla superficie terrestre, dal sogno alla realtà. Non credo che Hilmann fosse a conoscenza di queste porte perché ne avrebbe fatto un’ analisi. Annotazione a margine: le due porte nell’incisione hanno la forma di gioghi, costringono il viandante ad abbassarsi per attraversarle e questo è un altro segnale.
Il libro di Gea è per me laborioso in quanto mi induce al lavoro; per esempio comporre un poemetto su Alcimilla, un po’ come fece Mario Luzi con Ipazia, o un romanzo su Cornelia e le lotte sociali con lo stile della Pompei di Harris.
Il libro utilizza un metodo che risale a Varrone il quale stratifica la storia in tempi oscuri, tempi mitologici e tempi storici. Io sono orientato a un focus sull’oscurità immaginandomi nell’Accademia di Cicerone a dissertare sul fatto che l’universo è buio e che solo gli occhi e il cervello dei viventi trasformano le onde elettromagnetiche in colori e suono. Cicerone, da platonico, sempre un po’ saccente, aggrottando il triste supercilium, comincia a farmi un pistolotto sul mito della caverna. Meglio che vada via. La sua Accademia è diventata una stalla e tutt’oggi è abbandonata, non inclusa nei percorsi turistici. Gea mi ha informato di una tradizione che vedeva Enea come un predone e un traditore. Sebastiano Vassalli, che ignorava questa tradizione, lo ha descritto così nel romanzo “Un infinito numero”.
Ma ecco che entro in dissonanza cognitiva perché ho detto che amo i Campi Flegrei ma l’amore è un sentimento ambivalente. Nessun odio è più forte di un amore non corrisposto. Ho spesso sostenuto, beccandomi i reprimenda di amici puteolani, che “È un mito che i Campi Flegrei sono la terra del mito”. Che vuol dire? Che la storia del territorio non è mai appartenuta al vissuto dei suoi abitanti (conosco amministratori locali che non hanno mai visitato un sito archeologico), che i luoghi non sono mai stati visti come bene primario consentendo devastazioni pubblico-private e intensa urbanizzazione. Va annotato che la scelta dello sviluppo industriale negli anni pre e postbellici non ha favorito la percezione dell’importanza delle risorse locali. La Armstrong, che era un’importante industria bellica, disegnò a tavolino gli assi viari attuali, approvati a scatola chiusa dalle amministrazioni. Ad esempio, il c.d. stadio di Antonino Pio (forse, informa Gea, una villa ciceroniana) si estendeva verso il mare e fu tagliato. I contadini liquefacevano statue per ricavarne cemento ma la cosa riguarda anche il Rinascimento, quando venivano utilizzati i marmi dei reperti archeologici per costruzioni private. Fino al ‘700 vigeva il concetto di “vecchio”, non di “antico”. Pozzuoli prima del terremoto del 1538 era un importante centro termale. Le fonti ancora attive e non più utilizzate sono 21. L’industria termale trovò allocazione ad Ischia. Dopo il 1980 anche il litorale domitio, p. es. Licola, frequentato dal Presidente Leone e dal re Farouk, fu del tutto messo a soqquadro da ville che sono pollai liberty. Tralascio una situazione di trasporto pubblico disastrosa: sono eroi i turisti che da Napoli vengono nei Campi coi mezzi pubblici. Fanno eccezione gli studenti americani che ogni anno vengono ospitati a Cuma in una villa che gli americani vollero fosse inserita nel trattato di pace Italia-Usa.
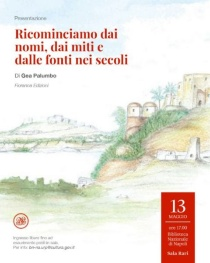
Dicevo che Gea mi ha riconciliato con ciò che vedo dalla mia finestra. La prima sensazione trasmessami è quella di un opus che rimarrà nella storia perché chiunque vorrà parlare dei Campi Flegrei dovrà leggere e consultare questo libro. Ho detto “opus” e penso a quello reticulatum e ai versi di Luzi “Anch tu sei nel gioco/anche tu porti pietre/ rubate alle rovine/ verso i muri dell’edificio”. Il volume parte dal nomen-omen, chiama le cose col loro nome segreto, per poi passare all’aura mitica del territorio e, contestualmente, alle fonti storiche. Le informazioni sono molte. Ad esempio, quelle sul nome “Procida”, dal quale prende l’avvio l’indagine, per parlare anche della Graziella-Nisieda di Lamartine che si ispirò a Charles Barimore del Conte di Forbin. In nota, scopriamo che Barimore, il suo autore, dimorò a Bacoli, presso la c.d. tomba di Agrippina. Mi piace, altresì, immaginare che il napoletano “Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo”, di Mary Shelley, che dimorò a Napoli, alla Riviera di Chiaia, e che certamente venne a conoscenza dell’opus del Di Sangro, sia stato concepito dalla giovanissima scrittrice dopo la visita all’antro della Sibilla. Frankenstein può essere il mossiere nel catalogo dei mostri che fa Virgilio.
Ho dichiarato che Gea mi ha fatto riconciliare con i Campi. Perché? Perché, leggendola, ho rintracciato nel mio occipite le tracce, appunto, di qualcosa di vagamente preciso, un’impronta che appartiene alla struttura della mente: il mito, inteso come archetipo; l’archetipo non è un’immagine o un simbolo ma la procedura attraverso la quale gli istinti trovano la propria autorappresentazione. Ha, cioè, sollecitato il mio subconscio, quella parte della mente che è vicina alla coscienza e che ho recuperato con quel campo di concentrazione che è questo libro. L’inconscio è invece, come si sa, una parte della mente che è lontana dalla coscienza e che richiede un lavoro psicoanalitico per essere rivelata ma so già che, volente o non, giungerò tra poco a toccare i margini dell’inconscio. Ed ecco allora che la finestra dalla quale vedo le cose si apre sul mio paesaggio interiore come una vibrazione musicale. La statua che sta sulla spiaggia e che guarda verso di me, annuisce. Informo che due fonosofisti armeni, ai quali ho fatto vedere il libro di Gea, hanno iniziato a lavorare sul paesaggio sonoro dei luoghi con la metodologia di Schafer.
Adesso,poiché il barbuto di marmo comincia a diventare inquieto, devo inoltrarmi nell’evocatività. La letteratura e le esperienze sul mito è molto vasta. Mi sono chiesto:“Quale immagine, in termini di mito, potrebbe rappresentare i Campi Flegrei secondo il mio sentire?”. Mi si è presentata la statua di una fanciulla appartenente al Ninfeo di Claudio e che regge in mano una farfalla. La farfalla, si sa, è il simbolo di Psychè, alata, della metempsicosi. La Psychè, l’anima, è un concetto platonico che, fino ad Agostino, era ignoto al giudaismo e al cristianesimo per i quali l’anima è la “nefesh”, il punto della gola dove ha origine il respiro e la parola. Quella fanciulla nella mia visione reca sotto il braccio il libro di Gea e mi conduce, psicopompa, a riformulare il senso di “Campi flegrei terra del mito”.
I Campi Flegrei sono inumani, paurosi, pericolosi, inospitali. Eppure, hanno qualcosa di sacro. Un giorno chiesero a Jim Morrison, il leader dei The Doors, di dare una sua definizione poetica di rugiada. Gli lessero questa definizione: ”La rugiada è una precipitazione dovuta a condensazione di vapore acqueo in forma di goccioline visibili sui corpi al suolo”. Morrison rispose: “Anche i fiori piangono ma ci sono stupidi che pensano sia rugiada”. Lo stesso vale per i Campi Flegrei: è una caldera vulcanica. Stop. Ma se intervengono mito e storia diventano qualcosa di sacro.
Cito Mircea Eliade: “L’essenziale riguarda l’immagine che l’uomo delle società arcaiche si è fatto di sé stesso e del posto che occupa nel cosmo. La differenza principale tra l’uomo delle società arcaiche e tradizionali e l’uomo delle società moderne, fortemente segnato dal giudeo-cristianesimo, consiste nel fatto che il primo si sente solidale con il cosmo e con i ritmi cosmici, mentre il secondo si considera solidale solamente con la storia”. Questa è anche la tesi di Galimberti.
Ecco allora il focus di Palumbo: indagare sull’uomo arcaico (mito) e su quello contemporaneo (storia).
Ma perché i Campi Flegrei sono stati vissuti come dimora del mito? Virgilio ne è stato l’amanuense e ne ha compilato l’inventario. Lo sono diventati perché essi si presentavano, e si presentano, come un big-bang permanente, ci informano sull’origine del cosmo così come percepito da tutte le culture e le cosmogonie. Certo: ci sono altri luoghi sulfurei, anche in Campania (p.es. Mefite, in provincia di Avellino, anch’essa citata da Virgilio, o Telese) ma non hanno rappresentato intrecci di culture né hanno prodotto arte, letteratura, architettura, non sono stati, cioè, attrattori ed indicatori di senso.
Nel paesaggio flegreo, dunque, si vede in azione l’inizio del tempo e chi va a ritroso nel Tempo deve necessariamente ritrovare il punto di partenza che, in definitiva, coincide con la cosmogonia. Sarà utile far parlare chi è venuto per la prima volta in questi luoghi. Octavio Paz, per esempio, che sostò a lungo nel tempio di Mercurio ricordando i monumenti aztechi, in particolare la “piedra del sol” e mi sussurrò:”E’ il più bel monumento del mondo. Monumento è ricordare”. Un’altra volta la poetessa brasiliana Marcia Theophilo entrò in trance davanti alla grotta della Sibilla ed evocò Juruparì, il dio della foresta india. Tutti i miei ospiti mi hanno confidato di trovarsi in un dejà vu, come se qui già ci fossero stati. Ripercorrevano, dunque, un processo mentale che conduce all’inizio del tempo per giungere al non-tempo, l’eterno presente che ha preceduto l’esperienza temporale fondata dalla prima esistenza umana decaduta (rieccolo il serpente dell’incisione). In altre parole, partendo da un qualsiasi momento e situazione si può giungere ad esaurire il senso della durata percorrendola a ritroso e sfociare infine nel Non-Tempo. Il fascinum di questi luoghi è precisamente questo. A Louise Gluk è stato conferito il Nobel soprattutto per il libro “Averno”, antro e rimedio della depressione, dimenticata grazie alla fonte del Lethe.
Ma cos’è il sacro? il sacro implica la terribilità, il timor sacer. Il sacro è il separato, il diverso, ciò da cui devo stare lontano in quanto minaccioso.
Sacer rinvia al sacer esto della legge latina per cui uno spergiuro, o colui che non rispettava le leggi, poteva essere assassinato da chiunque senza pagare pena. In quest’ottica, anche l’ Homo sacer di Agamben, la sua nuda vita, si declina in modo profondo.
Ma i Campi presentano – almeno per me – un altro fenomeno, l’ “a-lèteia”, il non-nascosto che si rivela come ciò che scompare prima di apparire. “Alèteia” e Lethe sono omologhi. Passeggiando nei Campi ci si trova spesso, come accade a me anche solo dalla mia finestra, in una Lichtung, una radura in cui l’essere si manifesta. L’Essere è simile a una foresta buia e intricata, dentro la quale vaga senza poter cogliere nulla in maniera oggettiva e distaccata. Lichtung è il termine attraverso cui Martin Heidegger esprime il luogo della rivelazione e del nascondimento dell’Essere e l’impossibilità di trovare per esso una definizione.
È nei momenti sacri che si manifestano i miti come struttura della mente, come accadde a Jung nei semptem sermones ad mortuos o con l’Abraxas del libro rosso. Ecco: mi azzardo a dire che quella fanciulla, nella dinamica junghiana animus-anima, è l’anima dei Campi Flegrei.
Vado un po’ più in profondità, attratto dal pulviscolo di atomi delle fumarole che vedo dalla mia finestra. Federico Faggin, inventore del microprocessore e creatore della Silicon Valley, dopo una sua personale esperienza, molto simile al delirio freddo col quale Cartesio intercettò il “Cogito”, in trentacinque anni di auto-osservazione ha elaborato una teoria che coniuga strettamente scienza e spiritualità toccando punti di raccordo con filosofi come Plotino, Giordano Bruno, Eraclito, Spinoza e altri, in particolare Hegel, per il quale lo Spirito si attua, ai fini dell’autocoscienza, nella storia. Per Faggin coscienza e libero arbitrio sono il manifestarsi di campi quantistici preesistenti al nostro esserci e di cui siamo parte, appartengono a un Uno dinamico, olistico, e che vuole conoscere sè stesso. I quanta generano aggregati di simboli che in noi diventano qualia, cioè il saper sentire, i sentimenti, la semantica. Se, come me, provate a leggere il libro di Gea con l’ottica di Faggin, vi troverete immersi in un sistema di relazioni unitario, olistico, vedrete il big-bang articolarsi nella storia umana mediante i simboli, appunto, del mito. Questo me lo ha sussurrato quella fanciulla.
Il volume procede per analisi, descrizioni,, ma ciò che mi intriga è da un lato la filologia dell’immagine (esemplare è l’analisi iconografica fatta da Gea relativa all’Accademia di Cicerone) dall’altro il sentirmi contemporaneo dei tempi delle storie narrate e mi sono divertito a leggere il libro al contrario, dai momenti più recenti a quelli più antichi, talvolta cambiandoli di posto, un po’ come Calvino ne “Il castello dei destini incrociati”.
Abbiamo parlato di Faggin e del superamento, grazie alla quantistica, della fisica newtoniana. Abbiamo anche detto che i Campi Flegrei rinviano al fascinum. Domandiamoci: abbiamo esperienza di qualcosa che ci consente di abolire la realtà così come la percepiamo, in modo newtoniano, e che ci conduce a esperienze diverse? Certamente. Questo qualcosa è il sogno, indeterminato e irrazionale proprio come la meccanica dei quanta. Nel sogno non vale il principio di non contraddizione (questa cosa è questa e non un’altra) ma il criterio dell’analogia (questa cosa è questa ma può essere anche un’altra). E qual è il mondo nel quale le cose sono insieme “questo e quello”? La poesia, l’arte, il mito che nei Campi si concentrano. Confesso che un giorno ho visto, nella solfatara, un bambino giocare a scacchi col guscio di una tartaruga: era il bambino divino di Eraclito.
Nella mia finestra comincia a scendere il freddo della motte. Ecco che lo scirocco muove i panneggi della statua sulla spiaggia, che comincia a muoversi come un golem. Mi guarda e mi fa cenno di seguirlo. Obbedisco. E’ strano: sulla sabbia non lascia impronte. Ha i lineamenti mediorientali. Mi indica il cielo stellato. Gli astrofisici mi dicono che il cielo che vediamo adesso, considerando il viaggio della luce, è lo stesso di 2.000 anni fa. Sul rione Terra hanno costruito una volta celeste con questo cielo. Ho capito: la statua è quella di Paolo di Tarso.
I Campi flegrei, litora mundi, hanno ospitato due extracomunitari, due uomini-progetto fondatori di civiltà, l’uno mitico, Enea, l’altro storico, San Paolo. E’ un evento che, interiorizzato da tutti, illumina i Campi. Seguendo Paolo, ho assistito al suo incontro con Enea, a Cuma, dopo 4.000 anni dal viaggio di Enea. Enea è la Pietas, Paolo la Charitas. Anche Paolo, come Enea, portava sulle spalle qualcuno: era il giovane eroe figlio del fuoco che governava un regno senza mura o porte Scee. Enea ha consegnato a Paolo carte salmastre con le rotte della navigazione e gli ha detto:” «alza vele di notte ed usa il vento /dell’ombra del tuo dio se sogna d’esser vento». Gli ha consegnato un vecchio astuccio con il ramo d’oro.
Come gesto d’amore per i Campi Flegrei queste cose le ho narrate in un testo di poesia, Passato Postumo, tradotto in arabo ed ebraico, inserito in una cartella d’arte edita con materiali poveri da IL LABORATORIO/le edizioni, dedicata a Mimmo Lucano e che reca una puntasecca di Mimmo Paladino raffigurante un migrante che, emergendo da onde nere, in punto di morte consegna al lettore il ramo d’oro della conoscenza.
Mimmo Grasso