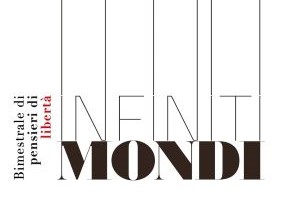Sul blog d’Infiniti Mondi, il dibattito sullo scenario di guerra e sulle trasformazioni tecnologiche, è interessante per le riflessioni di Nappi, chiedendosi quale futuro aspetti l’Europa, avvolta dal mito del libero mercato e i compiti per la sinistra, mentre M. Mezza nel suo intervento, dopo l’interessante libro “Connessi a morte” (2024), ragiona su effetti delle nuove tecnologie, potere e modalità delle guerre. Entrambi argomentano sulla svolta impressa da Trump con la politica dei dazi.
Nappi lamenta troppi sostenitori della globalizzazione. Certo, la globalizzazione è stata dominata dalle logiche brutali del mercato, contrariamente a Stiglitz che auspicava la sua regolamentazione. Invece, la speculazione finanziaria ha prodotto crisi e aumento delle diseguaglianze nei Paesi avanzati.
La globalizzazione, però, ha fatto anche crescere il Sud-Est asiatico, area con consistente sacca di povertà mondiale. La prima globalizzazione, nelle sue fasi finali, si era rivolta contro governi, perché l’apertura dei mercati, pur distruggendo le rendite, produceva effetti negativi su occupazione e imprese. Tra le due guerre mondiali erano sorte politiche di import-substitution per produrre in casa ciò che s’importava. La domanda di garanzie si era sposata con quella di imprese, banche e burocrazie per ripristinare il loro potere eroso dall’apertura internazionale e ridurre la concorrenza internazionale. I dazi avanzati da Trump possono riprodurre una situazione simile, alimentando anche scenari peggiori, mentre gli accordi commerciali tra Paesi sono il principale antidoto a che i conflitti non si trasformino in scontri bellici, come avvenuto in Europa con 80 anni di pace.
Le responsabilità della sinistra non sono tanto nell’accettazione acritica della globalizzazione, bensì di aver smarrito il rapporto e la rappresentanza delle classi disagiate ed escluse, particolarmente nella transizione tecnologica, ispirata al modello dei poli innovativi. E. Moretti (2013) ha illustrato tale modello, riferendosi agli Usa, ipotizzando che i lavoratori senza istruzione avrebbero ricevuto retribuzioni superiori alla media, se occupati nelle città dei poli innovativi. Non ha considerato, però, l’abbandono delle città sedi della manifattura tradizionale, con i senza istruzione divenuti i loser della globalizzazione. Oggi, negli USA, rappresentano i nuovi poveri, con aumento dei morti per disperazione (Case, Deaton, 2021), soprattutto nei bianchi, per l’esclusione percepita come insuccesso personale. La sinistra ha rappresentato solo gli istruiti, raffigurata da tecnici assurti al ruolo di tecnocrazia, mentre i più deboli affollavano le aree periferiche.
Oggi in Italia è diverso, perché tranne le aree più avanzate, il passaggio a nuove tecnologie con il piano d’industria 5.0 è frenato da regole contorte e bassi investimenti, esportando, specie dal Sud, giovani ricchi di capitale cognitivo e le città meridionali con popolazione, poco o niente istruita. Un ostacolo alla comunicazione vis-à-vis, essenziale, anche nell’epoca d’internet, per comunicazioni complesse. Il risultato è una sinistra italiana con il suo bacino elettorale ridotto alle aree centrali urbane, con istruzione e redditi più elevati, consegnando alle destre la rappresentanza degli sconfitti.
Mezza, centra l’analisi sulla nuova forma del potere, indotta da potenza di calcolo e connessione pervasiva, un aggiornamento tecnologico della “microfisica del potere” descritta da M. Foucault, non più centrata nello Stato ma potere disperso nel controllo individuale. Oggi, come nel Panopticon di Bentham, un solo uomo che sorveglia dall’alto come “l’occhio che tutto vede”, per Foucault, visti senza vedere chi sorveglia. Oggi più pervasiva e vicina a G. Orwell di 1984, con il computer nuovo Panopticon virtuale. Mezza s’ispira al “Capitalismo della sorveglianza”, (Zuboff, 2023), leggendo la fine della globalizzazione come ritorno al nazionalismo. Non certo un eldorado, con monopoli interni e le imprese senza concorrenti e incentivi a migliorare la qualità dei prodotti. Un mondo chiuso ai mercati finanziari, con maggior costo del danaro, con imprese a scaricarlo sul prezzo dei beni finali.
Oggi, l’economia va verso una “economia di guerra”, in corsa per armamenti, che non sono solo cannoni, perché le guerre sono ibride, con satelliti, connessioni virtuali e nuove tecnologie. Certo l’eccessiva accelerazione del Piano ReArm, sottraendo risorse alla coesione e assorbendo ingenti risorse finanziarie, rischia di ridurre o abbandonare interventi a contrasto di diseguaglianze, squilibri regionali e cambiamento climatico. Se la dotazione di strumenti di difesa è propria di ogni Stato sovrano, l’Europa è ferma nel passaggio da un insieme di Paesi divisi ad uno Stato federale. Non sorprende che il riarmo, anziché comunitario, sia demandato in prevalenza ai singoli Paesi.
Con una sinistra divisa sulle risposte alla guerra, il problema è come coniugare, sicurezza e politiche di promozione sociale, poiché la vera pace si raggiunge, gestendo i conflitti e rimuovendo le diseguaglianze, dando dignità al lavoro, oggi povero e privo di tutele.
Le connessioni non sono solo sorveglianza. Mezza richiama il libro di M. Castells (2013) con uso duale delle nuove tecnologie a costruire relazioni virtuali, superando i limiti dello spazio fisico con un percorso “ibrido”, emergendo dalla rete ad occupare spazi fisici. Pur a fronte di programmi fumosi e indeterminati, conta la partecipazione. Hirschman (1982) ha indicato il beneficio della partecipazione, ragionando sul cibo il cui risultato è di alimentarsi, ma mangiare, specie in compagnia, identificata come partecipazione, è un piacere. Partecipare conta più del risultato.
La sinistra deve ritrovare la partecipazione dei più deboli ed esclusi, in periferie urbane e centri storici, uscendo dal chiuso delle autocrazie autoreferenziali, per un ritorno al territorio, non solo securitario, bensì di sviluppo, valorizzandone le risorse anche nascoste. Certo è un compito difficile, per mancanza di un referente sociale, con la classe operaia indebolita dalla frammentazione in micro e piccole imprese, con quelle medie, rare e a proprietà estera, pronte a muoversi verso aree di minor costo del lavoro e tassazione, con blande normative su lavoro e ambiente.
La manifattura è nelle aree interne o peri-urbane. Qui va difeso insieme lavoro e ambiente, distrutto anche da comportamenti autolesionistici d’imprese e popolazioni. Difficile, perché si tratta di costruire coesione tra diverse figure sociali, superando la mancanza di referenti sociali interfacciando istituzioni prossime ai territori con l’associazionismo locale. Non impossibile, se si risponde ai bisogni e si ferma consumo di suolo e speculazione immobiliare, basi del capitalismo della rendita.
Achille Flora